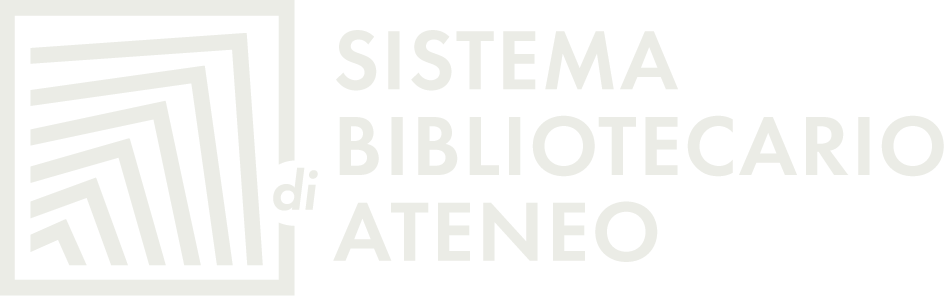Palazzo della Sapienza, Aula magna nuova
INAUGURAZIONE
DELL’ANNO ACCADEMICO 1990-91, 647° dalla fondazione
RELAZIONE DEL RETTORE
PROF. GIAN FRANCO ELIA
L’Università
italiana vive una stagione per molti aspetti nuova, effervescente, anche per i
provvedimenti legislativi - approvati o in corso di approvazione - e per il
vivace dibattito politico-culturale, che coinvolge direttamente le varie
componenti universitarie e che sembra consentire la realizzazione di nuovi
modelli di didattica e di ricerca.
I
mutamenti, attuati o annunciati, ci hanno indotto a presentare l’inaugurazione
dell’anno accademico non tanto come manifestazione celebrativa, ma come momento
di riflessione, di proposta, di impegno politico per la risoluzione dei più
impellenti problemi universitari; come un’occasione attraverso cui l’Università
si apre in forma solenne alla città per diffondere informazione e promuovere
condizioni di confronto con le istituzioni locali e, più in generale, con la
società.
Per
questi motivi abbiamo ritenuto opportuno modificare il consueto “taglio” della
relazione inaugurale, soffermandoci non su un’illustrazione descrittiva
dell’anno accademico trascorso, ma su alcuni eventi ritenuti strategici per
l’assetto presente e futuro dell’Ateneo e sui provvedimenti normativi (disegni
di legge sull’autonomia e sul diritto allo studio, leggi sugli ordinamenti
didattici e sul piano triennale di sviluppo) che sembrano potergli aprire nuove
prospettive.
La
legge istitutiva del Ministero dell’Università e della ricerca, consente agli
Atenei di approntare ed approvare i loro nuovi statuti e regolamenti. La realtà
pisana, per la presenza di tre Università e di importanti Enti di Ricerca come
il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, si rivela estremamente interessante per sperimentare e attuare questa
normativa.
Con
l’approvazione del disegno di legge sull’autonomia, in discussione al
Parlamento, e già approvato due giorni fa dalla Commissione Istruzione del
Senato, l’Università avrà finalmente il pieno diritto di scegliere e decidere,
di programmare e gestire la sua politica della didattica e della ricerca.
Intanto l’Ateneo pisano si è avviato su questa strada, e, fin dal gennaio dello
scorso anno, ha nominato due gruppi di studio: uno presieduto dall’ex Rettore
Bruno Guerrini, per predisporre la bozza dello Statuto di questo Ateneo;
l’altro, presieduto dal Pro Rettore Giorgio Cavallini, per elaborare i regolamenti
di amministrazione (che peraltro saranno discussi dopo l’approvazione dello
Statuto).
Il
Gruppo-Statuto ha presentato nel luglio scorso un documento con cui viene
delineato il nuovo ordinamento dell’Ateneo pisano; individuando i principi
generali, gli organi centrali di governo, le strutture, definendo, gli spazi
dell’autonomia finanziaria, contabile, organizzativa e regolamentare. Il testo,
diffuso tra tutte le componenti universitarie, è stato oggetto di un serrato
dibattito, al quale hanno partecipato docenti, non docenti e studenti.
La
procedura adottata, con cui si è cercato di contemperare elementi di democrazia
partecipativa e rappresentativa, è stata esplicitamente diretta ad arricchire
la fase istruttoria, preparatoria dello Statuto, ed ha evidenziato critiche e
consensi alla bozza predisposta, fornendo comunque indicazioni estremamente
significative.
Nella
storia nella nostra Università (ma anche in quella di altre) è forse la prima
volta che un documento di tale rilevanza viene preventivamente sottoposto al
giudizio critico e diretto dei destinatari (ferma restando l’indiscutibile
autorità decisionale del Senato Accademico Integrato), al fine di acquisire
suggerimenti utili a renderlo rispondente alle esigenze della collettività
universitaria.
Il
documento si è rivelato una solita base di discussione. Ma l’analisi non è
conclusa e riprenderà, nelle prossime settimane, fino all’insediamento del
Senato Accademico Integrato. Gli interventi raccolti nel corso del dibattito,
protrattosi quattro giornate, saranno trasmessi allo stesso Senato, che potrà
quindi disporre di un materiale di riflessione ricco e stimolante.
Al
Gruppo Guerrini va un sentito ringraziamento dell’Ateneo, per l’impegno
mostrato e soprattutto per la redazione di un testo cosi ampio e puntuale.
Al
disegno di legge sull’autonomia è legato uno degli eventi che hanno segnato lo
svolgimento dello scorso anno accademico, che è stato, come è noto, l’anno
della Pantera. Proprio per protestare contro questo disegno di legge gli studenti
di Palermo occupano, nel dicembre 1989, la Facoltà di Lettere e Filosofia. La
risposta iniziale degli altri Atenei italiani è varia: a Genova gli studenti si
insediano nella Facoltà di Lettere, a Bari in quella Lingue, a Roma in alcune
strutture universitarie. Ma nella seconda metà di gennaio 1990 le tensioni
studentesche esplodono e le occupazioni si susseguono in molte Università.
Nasce così il Movimento studentesco, che l’immaginario collettivo definisce
“Pantera”, proprio per significare la sua imprevedibilità, il suo ritirarsi dal
confronto con le istituzioni, il suo rifiuto dalla rappresentanza, la sua
inalterabilità e il suo sottrarsi alla trattativa.
A
Pisa le occupazioni iniziano, in varie forme, con la Facoltà di lettere, con il
Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico, con il Dipartimento di
Storia delle Arti (il 22 gennaio); proseguono con le Facoltà di Scienze
Politiche e di Veterinaria, con il Dipartimento di Linguistica, con la Facoltà
di Lingue e poi man mano con altre strutture.
In
mezzo a dibattiti estenuanti, ad assemblee senza fine, ed anche al diffondersi
dell’ideologia del telefono, del fax, della fotocopiatrice, cominciano ad
affiorare istanze, connesse con i mali antichi dell’Università italiana. E si
richiedono nuovi spazi e attrezzature, si rivendica l’esercizio di diritti di
comunicazione e socializzazione. Queste richieste sono per molti aspetti
fisiologiche e fanno parte della globale trasformazione e modernizzazione del
Paese. Laddove è possibile gli organi accademici concedono agli studenti spazi
e attrezzature.
Le
manifestazioni studentesche non provocano il minimo incidente. Dopo qualche
tempo, subentra la stanchezza di inutili esercizi retorici, la constatazione
dell’inconcludenza delle occupazioni, e forse anche il bisogno di riprendere le
lezioni. E così le aule vengono liberate.
All’inizio
di quest’anno accademico la Facoltà di Medicina è stata occupata per diversi
giorni: stavolta però per problemi attinenti all’organizzazione della didattica
che sono stati in gran parte risolti.
Pur
nelle ristrettezze del suo bilancio, l’Università stanzia una cifra a favore
delle attività e delle iniziative studentesche. Tra l’altro ha approntato un
progetto di informatizzazione, diretto a soddisfare con metodologie e strumenti
di lavoro avanzati, le esigenze connesse allo svolgimento delle pratiche
relative alla carriera di una popolazione studentesca che ha bisogno di ridurre
al massimo i tempi necessari all’espletamento delle pratiche amministrative.
La
principale novità del progetto, che vede Pisa all’avanguardia tra le Università
italiane, è di rendere attiva la partecipazione dello studente nella ricerca
delle informazioni relative alla sua carriera. Grazie al contributo della Cassa
di Risparmio di Pisa, si individua un progetto il cui carattere distintivo è
rappresentato da un sistema periferico costituito da terminali self-service,
attraverso cui lo studente può divenire soggetto attivo di operazioni di
informazioni generali e personali, di iscrizione, di formulazione di piani di
studio, di certificazioni varie. Sarà possibile rilasciare i certificati
richiesti in tempo reale, quando saranno risolti alcuni problemi legali. Dieci
terminali saranno installati in varie strutture universitarie e poi la Cassa
insedierà in altre città analoghi terminali collegati alla rete della Banca e,
tramite questa, all’Università. Cosi gli studenti potranno effettuare le
operazioni direttamente dalla propria sede di residenza. E in fondo è anche
questo un modo per rendere operante il decentramento universitario.
Dal
1984-85, ad oggi, il nostro Ateneo consegue un incremento percentuale di
iscrizioni pari al 15,5% ed ha 438 docenti di prima fascia, 672 docenti di
seconda, 78 assistenti, 529 ricercatori, 1573 unità di personale tecnico,
amministrativo e delle biblioteche e un patrimonio edilizio di 187 mila metri
quadrati.
Alcuni
dati relativi alla popolazione studentesca, che ammonta (compresi gli studenti
delle scuole a fini speciali, di quelle di specializzazione, dei corsi di
perfezionamento e di dottorato) a circa 37 mila unità e che da anni è in
continua e consistente crescita, concorrono ad evidenziare il progressivo
sviluppo della nostra Università.
In
uno studio di prossima pubblicazione, curato da docenti di sociologia e
statistica in collaborazione con il CEDA, risulta che, negli ultimi cinque anni
è cambiato il peso percentuale delle iscrizioni di varie Facoltà. Il maggior
numero di studenti si riscontra a Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (6.660
iscritti pari al 19,3 del totale), e poi a Economia e Commercio (S.262
iscritti), e a Ingegneria, a Giurisprudenza, a Lettere. Il corso di laurea più
frequentato è quello di Giurisprudenza (4.454 iscritti), seguito da Economia e
Commercio, Scienze dell’informazione, Lettere, Medicina e da altri.
Dato
non molto rassicurante, peraltro non esclusivo di Pisa, è la consistente
percentuale (31,1%) di fuori corso tra i nostri studenti. A questo si aggiunge
l’esigua percentuale (16,5%) di coloro che hanno sostenuto oltre due terzi
degli esami prescritti, il numero non trascurabile dei “fuori sede” che vivono
in condizioni precarie la loro esperienza universitaria (anche per il costo
altissimo agli affitti), la bassa percentuale dei laureati (circa il 25% degli
immatricolati).
Occorre
tener conto che circa la metà degli iscritti pisani proviene dalle province di
Pisa-Livorno-Lucca. Il 20% viene da Massa-Spezia-Grosseto e il rimanente 30% da
altre regioni. L’Ateneo è dunque in larga prevalenza frequentato da studenti
della fascia costiera, con quasi un terzo degli iscritti appartenenti ad altre
zone. L’attivazione di una politica di decentramento e imposta dalle capacità
di attrazione della nostra Università e dai suoi legami con altri centri.
Questi dati confermano che l’Università pisana non può irrigidirsi in una
politica di stretto municipalismo, essendo una realtà di portata nazionale e
internazionale.
L’entrata
in vigore della legge sugli ordinamenti didattici può aprire prospettive
migliori. Si tratta di una legge che innova profondamente l’Università italiana
e che può permettere al nostro Paese, con il diploma di primo livello, di
allinearsi su posizioni europee. A Pisa sono stati richiesti 30 corsi di
diploma, tenendo conto dei contenuti e degli sbocchi professionali.
Inoltre
l’istituzione di un Corso di laurea per i futuri insegnanti della Scuola
materna ed elementare e di una Scuola di specializzazione destinata agli
insegnanti di scuola secondaria potranno fornire ulteriori aperture didattiche
e formative.
Questa
prospettiva di qualificazione progressiva delle strutture didattiche e di
ricerca costituisce anche uno degli obiettivi con cui e stato predisposto il
piano triennale di sviluppo dell’Università 1991-93. Già approvato dal Comitato
Regionale di Coordinamento e inviato al Ministero, il piano si muove su due
direttrici: l’una tende a consolidare le attività tradizionali dell’Ateneo,
l’altra diretta ad attivare nuovi corsi di laurea, scuole di specializzazione,
ed a promuovere il rilascio di diplomi universitari. Inoltre nel piano è
avanzata la richiesta di potenziare il corpo docente e non docente, di adeguare
le strutture edilizie, obsolete o insufficienti, anche a causa
dell’imprevedibile incremento registrato nelle Facoltà umanistiche.
Le
nuove frontiere dell’Università rendono sempre meno evidente la differenza tra
scienze esatte e scienze umanistiche. La scienza e la tecnologia non possono
essere separate dalla riflessione teorica e culturale, ed anche dall’Ansia di
fantasia creatrice, di poesia che percorre l’uomo e il suo divenire. E va subito
detto che questo nesso può essere colto solo all’interno del sistema
Università, che è un sistema sui generis, poiché in esso ha luogo la formazione
della ricerca e l’accesso alla professionalità scientifica.
Il
sapere, prodotto e trasmesso dall’Università, non solo è scienza, è anche
cultura della scienza, ossia permanente consapevolezza delle implicazioni anche
sociali introdotte dalla razionalità scientifica.
Ciò
vale sempre. Ma vale soprattutto in questo nostro tempo in cui eventi
straordinari e imprevedibili obbligano a rivedere le abitudini mentali, a
superare steccati divenuti anacronistici tra i diversi versanti della scienza,
a ipotizzare e verificare nuove sintesi che esprimano più compiutamente i
molteplici e differenti valori conoscitivi provenienti da varie fonti.
È
stato affermato che la società dell’informazione concorre a far perdere alla
macchina la fisicità che l’ha sempre distinta dopo la rivoluzione industriale,
trasformandola in una sorta di entità immateriale. Su questa strada è stato
teorizzato, tra lo sconcerto di molti, l’avvento di una “macchina del
pensiero”, in grado di produrre nuove idee e nuove soluzioni in un mondo che
comporta sempre più stretti rapporti con le tecnologie. È stato anche
teorizzato, con altrettanto sconcerto, l’avvento di una macchina delle scelte e
delle decisioni. Problemi complessi e delicati, che non è il caso di
approfondire in questa sede. Certamente è all’interno dell’Università che vanno
salvaguardate libertà creativa e autonomia decisionale, ed è qui che scienza,
tecnologia e cultura devono potersi comporre in equilibrio.
L’Università
è in luogo privilegiato in cui le varie forme della conoscenza devono potersi
incontrare, perché sia restituito all’uomo il senso dell’unità della vita che
le crescenti incombenze del quotidiano tendono a disgregare. Si pensi solo alla
incidenza della innovazione tecnologica sui ritmi che regolano i processi di
mutamento.
La
risposta alla domanda: «mutamento per cosa, per chi e a che costo?» non può
allora essere lasciata cadere e anzi deve essere trovata mettendo a confronto,
in una dialettica globale, tutti gli ingredienti del sapere.
Preoccupazioni,
queste, che fanno da sfondo agli intendimenti operativi tesi ad ottimizzare lo
stato del nostro Ateneo.
Vengo
perciò agli interventi proposti per il settore edilizio.
Essi
prevedono la completa attuazione del polo didattico-scientifico di fisica,
matematica, informatica; il conseguente trasferimento di strutture delle
Facoltà umanistiche nei locali lasciati liberi dal Dipartimento di Fisica; la
realizzazione del polo biologico delle Facoltà di Medicina e Chirurgia in
Cisanello, la costruzione di una nuova sede per la Facoltà di Medicina
Veterinaria e attività coordinate agro-zootecniche, riservando quella attuale
all’espansione della Facoltà di Economia e Commercio, lo sviluppo della Facoltà
di Ingegneria con un primo lotto funzionale destinato ad una struttura
dipartimentale e a raccordi con altri enti per un’area di ricerca tecnologica
integrata, l’edificazione di una foresteria per docenti e studenti stranieri,
l’eliminazione progressiva delle barriere architettoniche. Alcune delle
suddette realizzazioni consentiranno inoltre ampliamenti adeguati per le
esigenze dei settori chimico e farmaceutico, di quello biologico e delle
scienze politiche e giuridiche.
Il
piano triennale individua poi nella crescita qualitativa e quantitativa del
personale tecnico, amministrativo e bibliotecario uno dei principali elementi
di sviluppo dell’Ateneo.
Se
all’adeguamento numerico del personale dovrà provvedere il Ministero
dell’Università e della Ricerca, questa Amministrazione, intende intervenire
per attuare pienamente e in tempi brevi le vigenti disposizioni legislative;
provvedendo quindi alla definizione della propria pianta organica e ad una più
efficace struttura organizzativa; operando per la crescita professionale del
personale con più intensa attività di corsi di aggiornamento; e con maggiore
attenzione alle condizioni di lavoro mediante provvedimenti, come l’istituzione
del servizio mensa, che, iniziato lo scorso anno, sembra fornire risultati
positivi.
In
questo contesto si inserisce l’intervento previsto relativo all’Attivazione di
infrastrutture generali, tra le quali un piano informatico diretto a dotare
l’Ateneo di strumenti gestionali moderni ed efficaci per l’amministrazione del
personale, la gestione finanziaria e contabile, L’office automation,
l’automazione delle biblioteche (che hanno un patrimonio di circa un milione di
volumi e di 800 mila periodici). E si inserisce altresì, un progetto per
potenziare le capacità di calcolo scientifico realizzando anche una rete di
comunicazione e trasmissione-dati che colleghi in sistema unico le diverse
strutture di questa Università.
Sul
fronte legislativo, i due provvedimenti essenziali, del cosiddetto
“quadrifoglio”, in discussione al Parlamento sono: la legge sull’Autonomia
universitaria, per superare l’assetto centralistico e la legge sul diritto allo
studio, per consentire ai capaci e ai meritevoli i livelli più elevati di
istruzione, e assicurare, agli studenti non solo un efficace quadro
assistenziale, ma servizi didattici e sociali adeguati.
Ma
sono essenziali anche altre innovazioni normative, come quelle inerenti i
meccanismi di reclutamento e di avanzamento di carriera dei docenti, la
definizione dello status giuridico dei ricercatori, la valorizzazione del
dottorato di ricerca, la costituzione di organici per il personale medico e
parasanitario.
Tutto
questo comporta consistenti oneri finanziari per l’amministrazione universitaria.
E quindi una diversa politica della spesa pubblica, perché, se si continuerà a
relegare gli stanziamenti universitari a livelli addirittura inferiori a quelli
concessi per effimere celebrazioni sportive, non riusciremo mai a raggiungere
le posizioni di altre Università europee.
Per
operare finalmente come agenzia primaria di didattica e di ricerca a livelli
elevati, e per adempiere alle funzioni che è chiamata a svolgere, l’Università
italiana ha bisogno di essere più concretamente sostenuta dallo Stato. Occorre
che il Governo riveda certi criteri che fino ad oggi hanno regolato, la
distribuzione delle risorse nel nostro Paese. Le carenze di aule, di
biblioteche, di laboratori, ed anche di spazi per studenti rischiano non
soltanto di generare processi conflittuali, ma di compromettere il progresso
sociale, economico, culturale, del Paese. Non si può certamente proseguire in
una politica che riserva alla ricerca scientifica soltanto l’1,45% del prodotto
lordo vendibile nazionale, ponendosi, in una condizione di grave inferiorità
rispetto ai paesi avanzati.
Di
fronte alla drammatica situazione finanziaria in cui viene a trovarsi anche la
nostra Università, ho ricevuto, dal Consiglio di Amministrazione, esplicito ed
unanime mandato di esprimere, in questa sede, la più ferma e vibrata protesta.
Il
caso della nostra Università è per certi versi emblematico, e per questo il
Consiglio di Amministrazione ha voluto adottare una singolare forma di denuncia
e di energica rivendicazione dei nostri diritti. Confidiamo anzi che la nostra
voce venga ascoltata e che magari si costituisca una opinione e uno
schieramento comune attorno ai problemi della Università.
Così
abbiamo presentato un bilancio preventivo, per il 1991, formalmente in pareggio
(così come la legge prescrive), ma insieme ad una relazione illustrativa che
evidenzia e calcola puntualmente il grave squilibrio tra risorse disponibili e
impieghi irrinunciabili.
Insomma
un bilancio reale accompagna quello legale.
Da
tre anni a questa parte l’Università italiana in generale e quella di Pisa in
particolare ricevono il medesimo stanziamento da parte dello Stato, senza
nessun incremento, nemmeno rapportato al tasso di inflazione. Quando poi - è il
nostro caso - L’Università vede aumentare in modo consistente la platea dei
suoi iscritti, diviene praticamente impossibile proseguire in una politica di
contenimento della spesa, a meno di compromettere il funzionamento delle stesse
strutture di base.
E
nel 1990-91, senza adeguati trasferimenti da patte della Stato, ci troveremo di
fronte a questa evenienza.
Per
quest’anno abbiamo ancora potuto attingere agli avanzi di amministrazione
realizzati dal 1980 al 1885. Ma, d’ora in avanti, esaurita questa risorsa
(anche perché all’Università sono stati sottratti gli interessi legati alle
cifre temporaneamente non utilizzate), la situazione appare gravemente
compromessa. E gli stessi, citati, provvedimenti legislativi non potranno
trovare efficace attuazione senza la corrispondente copertura finanziaria degli
oneri in essi previsti. Per realizzare l’autonomia occorre investire di più
dell’istruzione, nella formazione, nella ricerca, e forse di meno in altri
settori.
Le
nuove leggi consentono, è vero, aperture dell’Università a finanziamenti
privati, a cui del resto l’Ateneo pisano ha sempre attinto con contratti e
convenzioni, ottenendo risultati positivi per la formazione degli allievi, per
l’esperienza dei docenti oltre che per il conseguimento di determinati
obiettivi scientifici e tecnologici. Ma è anche vero che questo percorso deve
essere seguito senza compromettere minimamente l’autonomia universitaria,
rivendicando perciò al pubblico una costante supremazia nei confronti del
privato. E se, nel nuovo quadro normativo, l’una e l’altra sfera potranno porsi
come ruote dello stesso tandem, è il pubblico che dovrà essere chiamato a
scegliere la strada ed a guidare il veicolo. L’Università dovrà perciò, darsi,
in questo tipo di rapporti, una griglia di regole che non rischino di
compromettere valori come l’ambiente, la salute, la qualità della vita, la
pace.
In
questo quadro l’Università può serenamente stabilire fecondi rapporti con il
mondo della produzione e del lavoro, e soprattutto con le cooperative e gli
enti locali, con i quali possono essere assicurati servizi culturali, ricreativi,
orientativi, assistenziali, il problema di fondo è che gli organi di governo
universitario risultino consolidati nei loro poteri di scelta, di decisione, di
autonomia, di verifica e di controllo, mantenendo le loro prerogative
istituzionale; di fronte agli enti esterni.
Ma
ciò non può bastare a fronteggiare le molteplici esigenze del sistema
università. Lo Stato deve perciò intervenire con adeguati trasferimenti per
garantire le indispensabili risorse alle strutture universitarie e in
particolare alla ricerca di base; certo meno appetibile per interventi
“privati”.
Nel
nostro bilancio “reale” abbiamo voluto fondare il calcolo previsionale sulle
esigenze minime necessarie all’erogazione di servizi generali ed agli
interventi sul patrimonio. Il nostro scarto negativo non è neppure molto alto
(6,5 miliardi), ma deve essere eliminato. E se oggi, in relazione a ciò siamo
stati costretti ad operare una serie di tagli, in qualche caso laceranti, non
vogliamo peraltro abbandonare ogni illusione di poter costruire e organizzare
una Università all’altezza della modernizzazione in corso.
Parole
pesanti, ma meditate, che affettiamo alla riflessione responsabile di chi è
chiamato a governare il Paese, ma anche alle forze politiche e sindacali, ai
parlamentari, a chiunque intenda, insomma contribuire alla correzione di una
rotta universitaria che si rivela pericolosa per l’equilibrio sociale e
culturale.
E
poi il processo di internazionalizzazione in atto chiama l’Università ad
ulteriori responsabilità organizzative. Oggi, più che mai, l’Ateneo è tenuto ad
accentuare il suo ruolo internazionale, anche attraverso il numero crescente di
progetti a cui partecipa (Erasmus, Tempus Comett, Lingua, Esprit, Eureka), per
il suo inserimento attivo in quell’Europa che ha dato al mondo le Università e
che può trovare il proprio raccordo unitario proprio in una cultura
universitaria, che nasce dalla diversità dei paesi chiamati a farne parte.
Scienza, tecnologia, cultura possono trovare un terreno favorevole, di sviluppo
soltanto cimentandosi in un confronto che nasce da varie esperienze e modelli
culturali.
L’Università
di Pisa, può nei limiti indicati, cerca da tempo di fare il possibile per
promuovere la mobilità degli studenti e docenti, per attivare una serie di
accordi internazionali che vadano incontro ad istanze dirette a realizzare una
più stretta intesa scientifica e culturale tra i Paesi europei, compresi quelli
dell’Europa orientale.
Il
compito di sostenere la cooperazione tra i paesi della Comunità europea nel
campo delle tecnologie, e la conseguente collaborazione con imprese medie e
piccole, affidato al programma COMETT, ha trovato attuazione anche nei
consorzi; Università-impresa nel campo nella formazione. Le tre Università
toscane hanno costituito a questo scopo un consorzio regionale.
In
quest’anno accademico si verificano importanti e storici appuntamenti. Con
manifestazioni adeguate si celebrerà il quarto centenario di una prestigiosa
istituzione: L’Orto Botanico. E sarà anche questa un’occasione per testimoniare
l’impegno dell’Università ad attuare le indicazioni di politica musicale
espresse dalla Commissione Musei.
Inoltre
la Facoltà di Agraria celebrerà il 150° anniversario della sua fondazione, e
l’istituzione della cattedra di “Agricoltura e Pastorizia”, a cui fu chiamato
il Marchese Cosimo Ridolfi, agricoltore, cultore di studi agrari, deciso ed
autorevole propugnatore dell’idea innovatrice di “professare agricoltura
all’Università”.
Ma
in tema di appuntamenti storici c’è un’altra scadenza imminente di cui dobbiamo
occuparci fin da ora: la celebrazione da parte della nostra Università del suo
650° anno di vita. Una Commissione di docenti, presieduta da un altro ex
Rettore Ranieri Favilli, è già da tempo al lavoro per redigere, in due volumi,
una storia dell’Università di Pisa. Un’altra commissione sarà incaricata del
coordinamento delle manifestazioni e delle iniziative. Ma altre realizzazioni
dovranno accompagnare lo storico evento. E per questo chiediamo anche noi, come
altri Atenei il varo di appositi provvedimenti: al Parlamento Italiano e alla
Regione Toscana.
Intanto,
attuando un programma culturale tracciato nel 1990, organizzeremo, per la
prossima primavera, un convegno internazionale su Tecnopoli e Università,
presentando in quella sede, anche una proposta di tecnopoli nell’area pisana.
Per il 1992 è confermato il convegno internazionale sui problemi della Torre, a
cui l’Università non può non fornire il proprio contributo di attenzione e
riflessione. Per il 1993 avrà luogo il grande Convegno internazionale sulla
storia della nostra Università.
Concludendo,
è mio dovere ringraziare il Senato Accademico e il Consiglio di
Amministrazione, il personale docente e non docente e in particolar modo i
componenti della Giunta d’Ateneo, che hanno fornito un apporto davvero prezioso
nella soluzione di innumerevoli problemi. Un grazie dunque al Pro Rettore
Giorgio Cavallini, a Carlo Cipolloni, ad Anna Maria Galoppini, a Paolo Gianni,
a Virginia Messerini, a Ivano Morelli, a Piero Pierotti e a Franco Russo, per
l’entusiasmo con cui stanno prodigandosi in una molteplicità di settori
strategici, contribuendo a legittimare un esperimento di politica universitaria
certamente destinato a consolidarsi nel futuro.
Un
ringraziamento al Direttore Amministrativo, dr. Giorgio Coluccini, che assolve
il suo incarico con tratti di grande competenza e di eccezionale sensibilità.
Un
saluto cordiale agli studenti di questo Ateneo, con molti dei quali ho avuto
frequenti occasioni di incontro e di discussione.
Cominciamo
tutti insieme quest’anno accademico, consapevoli degli ostacoli che ci stanno
di fronte, ma con la volontà di costruire l’Università dell’autonomia contro il
centralismo, della programmazione democratica contro il dirigismo. E insomma
l’Università interprete delle istanze autonomistiche, di autogoverno e
autodeterminazione .
La
situazione è difficile, i problemi più impellenti ci chiamano: risorse,
statuto, ordinamenti didattici, programmazione adeguata al nuovo quadro
istituzionale, rapporti con il mondo produttivo.
Questa
Università ha contribuito non poco alla civilizzazione e al progresso del
Paese. E siamo certi che continuerà a farlo negli anni futuri. Di fronte ai
venti contrari che soffiamo contro di noi, assumiamo allora la massima di
Giambattista Vico “paiono traversìe e sono opportunità”. E andiamo avanti, se
non con ottimismo, con speranza fondata sulle grandi tradizioni, sul prestigio,
sulle energie del nostro Ateneo.
Con
questa ferma convinzione, dichiaro aperto l’anno accademico 1990-1991, 647°
dalla fondazione di questa Università.
Da: Annuario per gli anni accademici 1990-1995,
Università degli studi di Pisa.