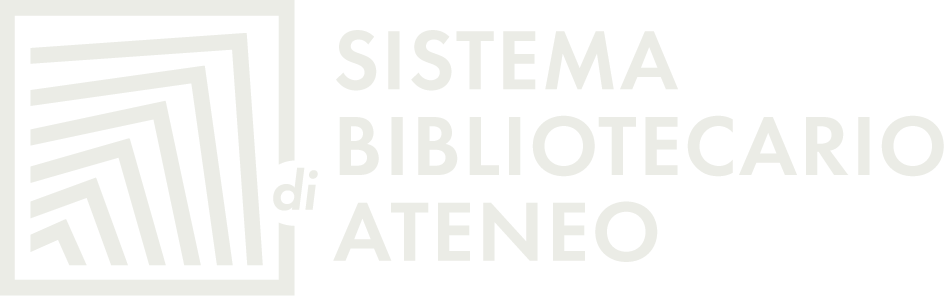Inaugurazione
dell’anno accademico 1994-95, 651° dalla fondazione
Relazione
del Rettore, prof. Luciano Modica
Signor Commissario Europeo per l’istruzione e ricerca
prof. Ruberti, Sua Eminenza Arcivescovo di Pisa mons. Plotti, Sua Eccellenza
Signor Prefetto di Pisa dott. Spirito, Signor Sindaco di Pisa prof. Floriani,
Sig. Presidente della Provincia di Pisa dott. Nunes, Autorità tutte civili e militari,
Magnifici Rettori, cari colleghi, cari studenti, cari dirigenti, funzionari e
collaboratori tecnico-amministrativi, gentili signore e signori, vi ringrazio
vivamente di essere intervenuti così numerosi, e da così lontano per alcune
persone care, a questa cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico che anno
dopo anno rappresenta il momento solenne e intellettualmente stimolante per
fare il punto e per disegnare il futuro della vita accademica dell’Università
di Pisa. Desidero in particolare ringraziare i colleghi rettori delle
università italiane ed europee che, dopo aver partecipato al convegno sulla
responsabilità europea delle università che stamane si è concluso e su cui in
seguito ritornerò, hanno accettato il nostro invito ad essere presenti in forma
solenne anche a questa occasione accademica. Mi è particolarmente gradito
leggervi l’elenco delle università qui rappresentate dai rettori o da loro
delegati, quasi ad anticipare e sottolineare la dimensione e la irrevocabile
scelta europea fatta dal nostro ateneo, come da moltissimi altri che formano il
sistema universitario del nostro continente.
Poco meno di un anno fa ho assunto le funzioni di
rettore di questa antica università, proprio nel corso del suo
seicentocinquantesimo anno accademico, a partire da quello del 1343/44 in cui
la bolla papale “In supremae dignitatis” riconobbe l’esistenza dello studio
pisano e ne legittimò l’attività accademica. Un anno dunque particolarissimo
per la celebrazione di questo anniversario, ma che poi si è rivelato denso
oltre ogni previsione di avvenimenti universitariamente importanti. Non tutto
potrà essere ricordato nel tempo relativamente ristretto in cui mi riprometto
di far rientrare questo indirizzo inaugurale anche per lasciar spazio agli
attesi interventi del prof. Mirri e del prof. Ruberti, quindi molti fatti e
molti dati numerici che pur sarebbero interessanti dovranno essere omessi. Ho
la speranza, perché da buon professore non mi sento di avanzare promesse e di
indicare tempi in campo editoriale, di poter offrire in seguito ai colleghi e a
tutti gli interessati specifici documenti che raccolgano in modo ordinato e, se
possibile, visivamente esauriente ed accattivante i dati più significativi
sull’attività dell’Università di Pisa.
Dovendo scegliere una linea espositiva e volendo
privilegiare la concretezza, mi sono risolto a seguire da vicino quel documento
che presentai nel settembre dell’anno scorso al corpo accademico come proposta
per le linee d’azione del nuovo rettorato per il quale erano state convocate le
elezioni. In questo modo meglio appariranno, come è giusto che sia, successi,
ritardi o insuccessi della azione di governo universitario.
Il primo tema era quello dell’autonomia universitaria, del nuovo statuto
e delle sue conseguenze.
Il nuovo statuto dell’Università di Pisa, primo della
sua storia che sia nella sua interezza risultato delle scelte interne e
autonome dell’ateneo nel doveroso rispetto solo di pochi principi cardine
fissati dalla legge, è stato approvato dall’organo costituente, il cosiddetto
Senato Accademico Integrato, nello scorso marzo, poi confermato nel luglio dopo
i pochissimi e marginali rilievi di legittimità e di merito avanzati dal
Ministero, infine emanato il 30 settembre e entrato in vigore lo scorso 10
novembre. Così Pisa è entrata a far parte della ancora piccola ma rapidamente
crescente pattuglia di università - una decina contandovi anche i politecnici e
gli istituti universitari con vocazioni specifiche - che hanno finora applicato
la legge (sarebbe giusto dire, la legge Ruberti) sull’autonomia universitaria
del 1989 dotandosi di uno statuto autonomo. Mi sembra tanto doveroso quanto
oltremodo gradito rivolgere qui il più sentito ringraziamento a tutti i
componenti del Senato Accademico Integrato, e in particolare al Rettore Elia al
quale sono succeduto e che ha presieduto quest’organo costituente durante la
maggior parte delle sue 80 sedute. Credo che ognuno di loro difficilmente
dimenticherà l’appuntamento che per quasi tre anni ogni lunedì mattina li ha
portati a discutere temi importanti e spesso perenni della realtà
universitaria, talora in modo estenuante ma sempre con un indimenticabile
spirito costruttivo e innovativo, con quell’aspetto dell’etica civile che mi
piace chiamare passione accademica e che ha ancora per fortuna molti
rappresentanti tra noi.
Il risultato di questo eccezionale lavoro è uno
statuto di cui credo il nostro ateneo debba essere fiero, uno statuto che fissa
con legittimo orgoglio universitario le coordinate interamente culturali della
sua attività ma che si apre senza remore sin dal suo primo articolo alla
collaborazione intensa con tutti gli enti pubblici e privati che possono
concorrere al raggiungimento dei suoi fini istituzionali, che sono lo sviluppo,
l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze. Uno statuto che accetta
esplicitamente la sfida della complessità connaturata alla storia e alla realtà
attuale dell’università di tipo europeo (ce lo ha ripetuto ieri nella sua
magistrale lezione il Premio Nobel Prof. Prigogine), ma che la racchiude in una
necessità di integrazione che è insieme assi orna e corollario della unitarietà
della cultura. Uno statuto che tra i suoi valori fondamentali, oltre a quelli
contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nella Costituzione
Italiana, sceglie di accostare volutamente ai valori universitari
irrinunciabili e costitutivi del libero confronto delle idee e della libertà di
insegnamento e di ricerca dei docenti anche i diritti degli studenti. Uno
statuto che amplia gli spazi della democrazia accademica ma che insieme fissa
con chiarezza compiti e limiti dell’azione dei suoi organi di governo. Uno
statuto che riflette l’autonomia da cui nasce in una accentuata autonomia
concessa alle sue strutture didattiche e di ricerca, facoltà e dipartimenti, e
alle sue strutture tecniche e amministrative, riordinandole nei compiti e nella
gestione con l’obiettivo di dare sempre maggiori efficienza ed efficacia a
tutte le attività dell’Università.
Dicevo poc’anzi: temi perenni dell’istituzione universitaria
sono quelli affrontati dallo statuto. Mi sia concessa a tal proposito una
piccola digressione storica. L’occasione del 650esimo anniversario ha stimolato
la pubblicazione di una imponente opera sulla storia dell’Università di Pisa,
cui si è dedicata una commissione di nostri storici presieduta dal prof.
Favilli e di cui è finora stato stampato il primo volume che copre gli anni dal
1343 al 1737. Al prof. Favilli, anche lui nostro rettore negli anni ‘70, e a
tutti i colleghi storici va il nostro ringraziamento perché l’opera è di
qualità davvero eccezionale e ha fruttato al nostro Ateneo sicuro e documentato
prestigio.
In questo volume sono per la prima volta pubblicati
gli statuti che la nostra università ebbe da Cosimo I dei Medici nel 1545, che
ebbero vita lunghissima durando praticamente sino all’epoca napoleonica. Di
questi statuti è stata rinvenuta una lettera dedicatoria del Rettore Scipione
Torquato, che ne era l’estensore, a Cosimo I. Nel 1544 (per la bizzarria delle
cifre della storia, si tratta esattamente di 450 anni fa) Scipione Torquato
così scriveva: “Novas leges sancire, ex quibus coetus hominum aliquis regatur,
semper ego multis de causis difficillimum existimavi”. E più avanti:
“Magistratuum creandorum, suffragiorum ferendorum, sententiarum dicendarum ius
formamque earum perscripsimus, facile ut omnes intelligant a me ocyi et quietis
Academiae huius rationem habitam fuisse”.
Come si vede il mio antico predecessore aveva avuto i
nostri stessi problemi e i nostri stessi intendimenti.
Il tema statutario mi appassiona, come credo si
senta, ma troppo lungo sarebbe descrivere i multiformi e spesso intricati
aspetti dello statuto. Posso però affermare, avendone fatta esperienza più
volte, e con me molti colleghi, che il nostro nuovo statuto ha attirato
l’attenzione e l’ammirazione di molti colleghi docenti e anche delle componenti
studentesche di altri atenei italiani.
E’ ovvio, peraltro, che uno statuto, pur frutto di
tanta riflessione e di tanto lavoro, è solo il punto di partenza di una lunga
azione di attuazione, appena incominciata. Vorrei ora renderne brevemente
conto.
Innanzitutto il prossimo mercoledì 30 novembre
saranno eletti i docenti che rappresenteranno nel nuovo senato accademico i
dipartimenti, raggruppati per affinità culturali in sei settori, e i
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in questo che si
caratterizza definitivamente come il massimo organo collegi aie di governo
dell’ateneo. Seguiranno in breve tempo le elezioni per i rappresentanti degli
studenti. Permettetemi a questo punto di rivolgere il mio ringraziamento al
nostro tradizionale senato accademico, formato finora per antica tradizione dai
presidi di facoltà che siedono qui accanto a me. In questo primo anno di
lavoro, soprattutto nei non pochi momenti difficili e nel turbinio delle
innovazioni, ho avuto sempre la sensazione rassicurante di avere nei colleghi
presidi di facoltà un sostegno intelligente, aperto, disponibile, fattivo. Sono
sicuro che la loro collaborazione continuerà e si estenderà anche nel nuovo
senato accademico di cui continuano di diritto a far parte. Mi sia permesso
anche salutare con particolare affetto Enrico Latrofa e Gino Malvaldi, presidi
fino a qualche giorno fa delle facoltà di ingegneria e di medicina, ora
sostituiti rispettivamente da Paolo Corsini e Mario Campa. Altrettanto
affettuoso il mio saluto ad Aldo Romagnoli, preside di veterinaria, che lascerà
dopo lunghissimi anni la sua carica e sarà sostituito da Dario Cianci. Anche se
sono ormai presidi esperti, e per me amici e collaboratori consueti, perché
hanno assunto la carica nel corso del 1993/94, sono pur sempre alla loro prima
inaugurazione di anno accademico Roberto Sbrana, che ha sostituito Carlo
Casarosa alla presidenza di economia, Elena Guarini Fasano, che ha sostituito
alla presidenza di lettere e filosofia Umberto Carpi eletto al Senato della
Repubblica, e Roberto Federici, che mi ha sostituito alla presidenza di scienze
matematiche, fisiche e naturali. Agli amici Casarosa e Carpi un ringraziamento
caloroso per l’importante contributo che hanno dato nel loro incarico di
presidi di facoltà. Un benvenuto e un cordiale augurio di buon lavoro a tutti i
nuovi presidi.
Al nuovo senato accademico appena costituito spetterà
di preparare in tempi brevissimi (lo statuto, dura lex sed lex, fissa i termini
in sei mesi) i regolamenti fondamentali che sono: il regolamento generale di
ateneo che conterrà le norme generali di funzionamento organizzativo di tutte
le strutture universitarie; il regolamento didattico di ateneo che conterrà le
norme generali di esercizio dell’attività didattica Ce qui ritorneranno in
prima linea, è un preciso impegno che prendo, le questioni legate
all’insopprimibile diritto degli studenti di avere un insegnamento di qualità
ma anche regole certe per lo svolgimento dei corsi e dei relativi esami) così
come gli ordinamenti di tutti i curricula formati vi offerti dall’ateneo;
infine, il regolamento delle attività amministrative, finanziarie e contabili,
atteso con comprensibile e perfettamente condivisa ansia, soprattutto dai
direttori di dipartimento affinché i troppi inutili lacci burocratici posti
alla loro attività vengano definitivamente sciolti. Speravo invero di poter
licenziare durante il 1993/94 questo regolamento. Qualche ritardo si è invece
purtroppo verificato, anche per il rispetto di una normativa statale alquanto
complicata e frequentemente variata, ma siamo tutti al lavoro duro affinché
questo documento possa entrare in vigore già nei primissimi mesi del 1995.
Colgo l’occasione per esprimere un ringraziamento
particolarmente sentito a tutti i direttori di dipartimento che hanno svolto o
stanno svolgendo il loro impegnativo compito, avendo la responsabilità delle
unità operative dell’altra distinta rete organizzati va, quella dei
dipartimenti rispetto a quella delle facoltà, in cui si struttura il nostro
ateneo. Solo il loro numero mi impedisce di citarli personalmente, come invece
volentieri farei e come vorrei che ognuno di loro sentisse che io abbia fatto.
Lo statuto ha chiaramente riconosciuto l’importanza primaria, e in nessun modo
sussidiaria, della rete dipartimentale per tutte le attività istituzionali,
siano esse di ricerca o didattiche. Ne è un segno esplicito il definitivo riconoscimento
statutario attribuito al collegio dei direttori dei dipartimenti e dei centri
interdipartimentali, organo sperimentale creato dall’indimenticabile Enrico
Campanile, purtroppo recentemente e prematuramente scomparso, e che ho avuto
l’onore e il piacere - mi scuso per l’accenno personale - di presiedere per
qualche anno, ricavandone una parte importante e solida della mia visione della
gestione universitaria ma anche, per la conoscenza di colleghi dal carattere,
dalle esperienze accademiche e dall’impegno politico universitario assai
vicini, alcune delle mie più profonde amicizie personali.
Alla scelta irrevocabilmente dipartimentale del nuovo
statuto non si è certo arrivati ex abrupto. Negli scorsi quattordici anni un
organo specifico, la commissione di ateneo per la sperimentazione organizzativa
e didattica, ha preordinato e regolato l’organizzazione dipartimentale, a rigor
di termini rimasta sempre sperimentale dopo il decreto 382 del 1980 fino
all’adozione del nuovo statuto. Il lungo lavoro della commissione di ateneo può
dirsi che abbia avuto intero e lusinghiero successo, proprio per l’esito di
quelle norme statutarie, tra cui pure vi è quella che ne decreta la
disattivazione. A tutti i componenti della commissione di ateneo in questi
lunghi anni, ma soprattutto al suo ultimo presidente Roberto Mirandola,
succeduto qualche anno fa ad Enrico Campanile, e all’infaticabile segretario
prof.ssa Rosella Ferraris Franceschi va la sentita riconoscenza di tutto
l’ateneo.
Il caso, non so bene se dispettoso o favorevole, ha
voluto che, in questo stesso anno accademico 1993/94 in cui i temi statutari e
dunque di autonomia venivano al loro compimento, anche il Parlamento approvasse
la legge 537 del 28 dicembre 1993, legge di accompagnamento alla finanziaria
per l’anno 1994, che, soprattutto con l’art. 5, costituisce l’improvvisa messa
in opera della più ampia autonomia finanziaria dell’università che mai ci si
aspettasse, ben più ampia di quella che era prevista dalla legge sull’autonomia
del 1989 già citata.
Improvvisamente, cioè, alle università si comunicava
che il finanziamento statale ordinario annuale - circa il 75% del bilancio
complessivo di ogni ateneo - invece che suddiviso in una miriade di singoli
finanziamenti già destinati a scopi specifici e in un grosso finanziamento
destinato agli stipendi dei dipendenti, sarebbe pervenuto a partire
dall’esercizio finanziario 1994 in un’unica tranche senza destinazioni
ministeriali preordinate. Avrebbero poi le università deliberato come spendere
questo finanziamento, naturalmente essendo in ogni caso obbligate a coprire le
spese obbligatorie del proprio personale docente e non docente, pur sempre
statale, non lo si dimentichi. Inoltre ampia libertà, entro un famoso tetto di
1.200.000 lire per studente, era data alle università per l’imposizione delle
tasse e dei contributi universitari. Infine, novità tendenzialmente ancor più
rilevante, la dotazione organica del personale docente e non docente da
nazionale diveniva di ateneo, con la corrispondente ampia libertà di modificare
questa dotazione nell’ambito del finanziamento ordinario, l’ormai proverbiale
budget. Tralascio, per semplicità e per non annoiarvi, le altre, pur importanti
e positive innovazioni contenute nello stesso art. 5 e nel successivo art. 6, poi
purtroppo congelato nello scorso maggio dal governo Berlusconi.
Più volte ho detto che questo articolo della
finanziaria 1994 è stata la prima reale legge di riforma del funzionamento
delle università italiane nel dopoguerra, operando un taglio netto con il
passato e una vera rivoluzione copernicana. E delle rivoluzioni infatti ha
avuto le conseguenze tipiche. Dapprima l’incredulità generale che il nuovo
regime potesse davvero realizzarsi (siamo il paese del Gattopardo, e qualche
dubbio sempre ci assale in simili frangenti), poi il terrore che stavolta si
era fatto davvero sul serio, poi il lento adeguamento alle nuove regole. Ho
volutamente esagerato i termini, per segnalare per contrasto che invece tutte
le reazioni del sistema universitario italiano, pur rispettando lo schema
indicato, sono state di segno assai più confortante, e a Pisa in special modo.
Intendo dire che, forse imprevedibilmente, il sistema
universitario italiano nel suo complesso si è dimostrato assai più pronto
all’innovazione di quanto si dica di solito, stupendo, e ne sono testimone
diretto, anche alcuni dei responsabili dei sistemi universitari degli altri
paesi dell’Unione Europea. Non sono mancate certo proteste e lentezze,
polemiche e volute incomprensioni, non sono purtroppo mancati, nemmeno da parte
del Ministero che pure si era impegnato in senso diverso, atti anche recenti in
cui l’impostazione budgetaria è stata rinnegata a favore di interventi
straordinari diretti a singole università, alcuni ragionevoli come quelli verso
le nuove università lasciate in mezzo al guado dal cambiamento introdotto dalla
finanziaria, altri meno; ma nel suo complesso i tradimenti sono stati pochi e
limitati in valore anche se dolorosi per chi si è visto tradito, e invece la
reazione complessiva ha portato sia il Ministero, sia le singole università a
far maggior ordine nei loro conti, a compiere scelte coraggiose di bilancio, ad
impostare in modo assai più soddisfacente che in passato le strategie per il
loro futuro.
Qui nel nostro ateneo, sin dal primo momento in cui
presentai le novità legislative e gli atti che ritenevo conseguenti ad esse
agli organi di governo e poi ai responsabili di tutte le strutture didattiche e
di ricerca in un seminario che tenni nello scorso maggio, la convinta adesione
senza infingimenti della maggior parte dei colleghi al nuovo sistema e alle
proposte che vi collegavo mi ha molto incoraggiato e, non lo nego, talora
entusiasmato al vedere il desiderio di innovazione prevalere sul pur naturale
istinto di conservazione, l’interesse di lungo periodo per il benessere
dell’istituzione prevalere decisamente su altri calcoli opportunistici di breve
periodo.
Non è certo novità da poco, per fare gli esempi più
facili a comprendersi, che i posti vacanti di professore o ricercatore, pur
presenti e rimanendo nell’organico di ateneo, non siano automaticamente
associati ad una retribuzione, e che quindi ogni scelta di copertura dei posti
in organico è sottoposta ad una valutazione per la sua copertura economica,
valutazione che prima o poi diventerà anche di convenienza in termini di
bilancio e quindi di altre possibili destinazioni. Oppure che i denari finora
impiegati per le supplenze dei docenti o per le ore di straordinario del
personale tecnico-amministrativo possono venir destinati a qualunque altra
iniziativa, sempre in termine di valutazioni di convenienze e alla luce di
obiettivi predeterminati.
Non è stata poi novità da poco il poter e dover
stabilire il nuovo sistema di tassazione per gli studenti. Tralascio, perché
non riguarda il nostro ateneo ma si noti che anche questa è pur sempre stata
una nostra scelta politica, il problema del superamento del tetto di 1.200.000
lire che qualche università, talora con buone ragioni e con l’appoggio degli
studenti, ha realizzato in base ad un decreto legge autorizzativo più volte
iterato ma finora non convertito in legge. L’Università di Pisa, dopo un lavoro
di analisi tecnica quasi senza confronti in Italia, ha disegnato un sistema di
tassazione, ispirato a quello già in vigore sperimentalmente all’Università di
Venezia, certamente complesso ma unanimemente riconosciuto anche da esperti non
universitari o da organi di stampa indipendenti come il Sole-24 Ore come uno
dei migliori tentativi nella direzione di rendere equo il prelievo a carico
delle famiglie degli studenti, in base al reddito e al patrimonio familiare e
al merito dello studente. Do atto molto volentieri ai nostri studenti, dai loro
rappresentanti in consiglio di amministrazione fino a tutti coloro che hanno
partecipato alle varie assemblee su questo argomento, una delle quali convocata
nello scorso settembre dallo stesso rettorato, di aver compreso pienamente e
direi sostanzialmente approvato lo spirito del nostro nuovo sistema di
tassazione, ferma restando la estesa contrarietà del mondo studentesco, ma
direi di tutto il mondo universitario, alla mancanza di maggiori impegni
finanziari regionali e statali per il diritto allo studio.
Non ci si meravigli che dico impegni finanziari
statali, quando so bene che il diritto allo studio è di competenza regionale.
Ritengo infatti assolutamente fondamentale, anche per ragioni politiche
strategiche del nostro Paese, che agli studenti italiani sia offerta sempre
maggiore possibilità di scelta tra le molte università, 65 per l’esattezza in
Italia ma dell’ordine del migliaio se passiamo come sarebbe opportuno alla
scala europea, che loro offrono una sempre più ampia varietà, per temi,
obiettivi e, perché non dirlo, qualità di percorsi formativi. Per quanto
riguarda l’Italia, ogni confinamento regionale o macroregionale del mondo
studentesco deve essere evitato con un’attenta politica di sostegno economico
agli studenti capaci che ne hanno bisogno per perseguire la loro scelta
professionale.
Del resto una delle sfide che discende dall’autonomia
è quella di una maggiore competitività, in tutti i campi, delle università. La
nostra università è pronta ad accettare questa sfida, anzi la ritiene una
opportunità da cogliere, e per essa si sta attrezzando.
Tornando al nuovo sistema di tassazione studentesca,
il suo accoppiamento all’autonomia di bilancio di cui si è prima parlato, ha
permesso anche l’adozione di una importante norma di indirizzo politico,
anch’essa unica o quasi unica in Italia, che ha limitato al 10% l’aumento
complessivo stimato del gettito delle tasse studentesche, impegnando
l’eventuale sovragettito non stimato per carenza di dati esatti sui redditi e i
patrimoni delle famiglie degli studenti ad ulteriori servizi di diritto allo
studio.
Anche se mi piacerebbe, non posso illustrare i
dettagli del sistema di tassazione.
Mi basta qui ricordare l’eliminazione delle fasce di
reddito con le conseguenti ingiustizie per le forti disparità tra studenti al
salto di fascia; la considerazione separata delle detrazioni per reddito e per
merito in modo che solo studenti di famiglia non abbiente e contemporaneamente
meritevoli abbiano l’abbattimento totale o quasi totale della contribuzione, ma
a detrazioni anche significative possano accedere studenti meritevoli e
mediamente abbienti, oppure studenti non abbienti anche se non con alto
rendimento scolastico; la valutazione ponderata di molte cause aggiuntive di
difficoltà per gli studenti o per le loro famiglie (dalle famiglie con più
studenti universitari a quelle con familiari portatori di handicap, agli
studenti fuori sede, etc.), l’istituzione di premi di laurea anche abbastanza
cospicui per tutti coloro che si laureano in corso o nel primo anno fuori
corso, quasi ad evidenziare l’interesse forte e strategico che il nostro ateneo
ripone nella necessità di abbreviare il corso degli studi che per troppi
studenti universitari ha superato ogni ragionevolezza, non senza qualche
responsabilità anche dei docenti universitari.
Fortunatamente il nostro statuto ci dà già i mezzi
per affrontare con sicurezza di attribuzione di responsabilità decisionali i
nuovi compiti di autonomia budgetaria che ci sono stati assegnati. Inoltre,
come già prima accennavo, è già in corso lo studio preparatorio per arrivare ad
un’autonomia budgetaria che scende dall’intero ateneo alle facoltà e ai
dipartimenti. Saranno queste strutture universitarie a dover indicare la
destinazione dei fondi loro assegnati, individuando priorità ed effettuando
scelte, spesso non facili. Sono certo, per l’esperienza fatta quest’anno a
livello di ateneo nei confronti del Ministero, che dopo qualche iniziale
difficoltà il nuovo sistema permetterà un’efficienza e un livello di
soddisfazione degli utenti, docenti come studenti, decisamente migliore
rispetto all’attuale. Naturalmente sarà chiesto alle strutture di analizzare le
loro scelte in termini di reali costi, ivi compresi quelli per il personale,
per la manutenzione della struttura, etc., e dei corrispondenti benefici, e di
impostare credibili programmi annuali e pluriennali, esattamente come è tenuta
a fare statutariamente l’università.
Qui bisogna ammettere che siamo in qualche ritardo.
L’affollarsi delle scadenze ha finora impedito di preparare il programma
annuale di attività per il 1995 e il piano pluriennale di sviluppo previsti
dallo statuto, anche se siamo a buon punto per il bilancio preventivo 1995 che
prevediamo di approvare a metà dicembre e che, in certa misura ma solo
parzialmente, rappresenta un programma annuale implicito in scelte di bilancio.
Un illustre rettore, anzi direttore della Scuola Normale, poi senatore della
repubblica, Edoardo Vesentini, ama spesso ripetere che l’inaugurazione di un
anno accademico dovrebbe consistere da parte di un rettore nella semplice
esposizione delle linee generali del bilancio. Tolta la quota di raffinato
paradosso intellettuale o, se si vuole, di understatement implicito
nell’affermazione di Vesentini, io mi trovo abbastanza d’accordo e avrei
sperato di poter oggi dedicare una parte di questo intervento al bilancio 1995.
Non sono in grado purtroppo, se non per qualche accenno che serva almeno da
promemoria per il 1996 ma che in alcun modo vuole anticipare le scelte del
consiglio di amministrazione.
Quest’organo si è quasi totalmente rinnovato nella
scorsa primavera. Colgo l’occasione per ringraziare per il loro importante e
duro lavoro quanti l’hanno lasciato (Giuseppe Armani, Stefano Bombardieri,
Enrico Bonari, Paolo Ceccarelli, Carlo Alberto Cocconi, Riccardo Faucci, Walter
Grassi, Paolo Meletti, Mario Petrini, Roberto Tongiani, gli studenti Serena
Detti e Luca Spataro e, come rappresentanti del governo o di enti esterni,
Leonetto Amadei, Sergio Cortopassi, Ilario Luperini, Luigino Spanedda) e quanti
sono entrati a fame parte (Fausto Calderazzo, Moreno Citi, Carlo Da Pozzo,
Alessandro Faldini, Daniela Gianfaldoni, Giampaolo Gorini, Roberto Lorenzi,
Federico Massantini, Ferdinando Pentimone, Lucio Verrazzani e lo studente
Camillo Cardelli). Un saluto affettuoso tutto particolare a Marco Carcassi,
unico universitario consigliere di amministrazione confermato nel rinnovamento
del consiglio. Nel corso del 1995, come prevede lo statuto, saranno tenute le
elezioni per i membri del nuovo consiglio di amministrazione, ampiamente
modificato nella sua composizione, che entrerà in funzione all’inizio dell’anno
accademico 1995/ 96.
Il nostro ateneo avrà presumibilmente entrate nel
1995 per 330 miliardi, avendo già detratto le poste tecniche ininfluenti come
le partite di giro. Di questi 265 verranno dal Ministero dell’Università, 30
dagli studenti dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di
perfezionamento, 20 dai contratti di ricerca con enti pubblici e privati,
compreso il CNR e la CEE, 13 dalla regione per gli assegni al personale
universitario impegnato in attività assistenziali del servizio sanitario
nazionale, 2 da altre entrate.
Le uscite, naturalmente a pareggio, ammonteranno a
circa 240 miliardi per gli stipendi al personale docente e non docente sia di
ruolo sia assunto a tempo indeterminato o determinato, a 20 miliardi per le
borse ai dottorandi di ricerca e agli specializzandi, a 10 miliardi (troppi, mi
sia concesso) per le spese dei principali servizi (ENEL, pulizie,
riscaldamento, altre utenze), a 5 miliardi per le spese generali dell’ateneo, a
25 miliardi per le spese sostenute da facoltà e dipartimenti sia per le spese
generali, sia per la ricerca, sia per le attrezzature didattiche. Restano così
da assegnare circa 30 miliardi per coprire le spese per l’edilizia e per le
attrezzature didattiche di uso generale, sia di manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia di acquisizione immobili e per nuove costruzioni, e molte
altre voci di spese importanti e irrinunciabili ma non facilmente raggruppabili
almeno allo stato attuale della preparazione del bilancio. Un facilissimo
conteggio in base al patrimonio immobiliare del nostro ateneo mostrerebbe che
questa cifra sarebbe già insufficiente per la manutenzione ordinaria e
straordinaria, e credo che non ci sia spiegazione più esauriente di questa per
dar conto del degrado edilizio che purtroppo caratterizza quasi uniformemente
le nostre strutture. Tornerò più avanti sul problema dell’edilizia.
Ecco infatti che, pur avendo finora visto con qualche
spirito ottimista i problemi finanziari interni, non si può non segnalare, come
ogni anno ogni rettore è costretto a fare, la carenza del finanziamento statale
ordinario complessivo per il sistema universitario italiano, al di sotto di
tutte le medie europee rispetto al numero di studenti, rispetto al numero di
professori, rispetto al prodotto interno lordo. A questo si aggiunge la
mancanza assoluta, ormai da qualche anno, di nuovi finanziamenti straordinari
per l’edilizia universitaria. Ritengo assolutamente miracoloso che in queste
condizioni il nostro sistema universitario sia sopravvissuto e trovi ancora
forti e diffusi stimoli all’impegno dei singoli professori, studenti e
funzionari. Si comprende bene come le condizioni della finanza pubblica non
permettono grandi speranze di miglioramento per il futuro più prossimo, ma
sarebbe già un segno importante l’individuazione del sistema della formazione e
della ricerca come uno dei comparti strategici dell’economia del nostro Paese,
come lo è già nell’Unione Europea (basta scorrere quel testo eccezionale che è
il libro bianco di Delors) rispetto alla competizione mondiale globale, e
quindi la destinazione ad esso di un apposito piano pluriennale di
finanziamenti significativi e crescenti.
Sarebbe un segno importante, inoltre - e mi è stata
data occasione di esporre questo punto direttamente al Ministro Podestà durante
il convegno universitario di Padova dello scorso giugno e durante la riunione
della conferenza dei rettori dello scorso ottobre - che il Ministero preparasse
suoi strumenti e indici di valutazione dell’attività, sotto tutti gli aspetti,
delle università e in base ad essi, con trasparenza ed assunzione di
responsabilità. suddividesse una quota ampia degli incrementi di finanziamento
alle università. La nostra autonomia, di cui siamo gelosi e insieme convinti
sostenitori, comporta grandi responsabilità e quindi anche la necessità di
un’attenta autovalutazione; ma non rifiutiamo per nulla, anzi lo auspichiamo,
che i nostri conti e il mantenimento dei nostri programmi di funzionamento e di
sviluppo siano attentamente valutati e alle valutazioni positive seguano
corrispondenti interventi finanziari.
Lanciati nello stagno dell’autonomia, abbiamo
rapidamente imparato a nuotare nell’acqua piuttosto bassa dei finanziamenti;
togliercene ancora significherebbe soffocarci e quindi inevitabilmente
l’autonomia stessa ne sarebbe uccisa per molti anni, dando ragione a quanti ne
diffidavano; darcene in più con continuità e sicurezza significherebbe invece
la crescita vitale e autocontrollata dell’autonomia e quindi del sistema
universitario italiano.
Molte altre sarebbero le conseguenze dell’autonomia che vorrei
illustrarvi, ma non voglio abusare della vostra pazienza, se non desiderando
concludere questa prima parte del mio intervento con un accenno ai prorettori.
Il nuovo statuto prevede che il rettore si avvalga di prorettori da lui scelti
e nominati con indicazione di compiti e settori di competenza, i quali
rispondono singolarmente e direttamente al rettore che si assume la responsabilità
del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. Tra di essi è
compreso il prorettore vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni in
caso di impedimento o assenza. Questa norma statutaria è stata sperimentalmente
anticipata già nel corso del passato anno accademico, e devo affermare che è
risultata una delle esperienze più felici di questo mio primo anno di
rettorato. Avere accanto dei colleghi di eccezionale disponibilità ed efficacia
di azione, immediatamente divenuti anche amici affettuosi quando già non lo
fossero prima, ha rappresentato il mio reale punto di forza e di sostegno sia
nell’attività giornaliera sui singoli problemi, sia nella attività di
programmazione del rettorato, senza mai alcuna loro esorbitanza verso compiti
di governo che spettano agli organi a ciò istituzionalmente preposti ma con una
dedizione all’istituzione che non posso dimenticare e di cui qui rendo atto
ringraziandoli calorosamente uno per uno: Guido Paduano, prorettore vicario e
delegato ai problemi del personale tecnico - amministrativo, delle biblioteche
e dei rapporti culturali con la città, Gianfranco Denti, prorettore per
l’attività didattica, Aldo Frediani, prorettore per l’edilizia e
l’impiantistica, Mario Mariani, pro rettore per le questioni dell’assistenza
sanitaria, Alberto Massera, prorettore per gli affari giuridici, Paola Miolo
Vitali, pro rettore per l’organizzazione amministrativa, Franco Strumia,
prorettore per la ricerca scientifica e tecnologica, Marco Tangheroni,
prorettore per i rapporti con i dipartimenti. Quest’ultimo si è dimesso prima
della sua recente partecipazione come candidato alla elezione del sindaco di
Pisa; seguendo un ‘suo stesso suggerimento, poiché è entrato in funzione il
collegio dei direttori di dipartimento, si è ritenuto che i rapporti con i
dipartimenti potessero essere meglio gestiti tramite quest’organo consultivo e
in particolare tramite il suo presidente Enrico Bonari, senza necessità di
creare uno specifico prorettorato ma sicuro di poter contare sull’esperienza dell’amico
Bonari. Un nuovo prorettore è stato invece nominato qualche giorno fa nella
persona di Lorenzo Calabi, prorettore per le relazioni internazionali e in
special modo per quelle nel campo della didattica, desiderando dare indicazione
specifica dell’importanza che si annette allo sviluppo dei programmi di
mobilità studentesca e docente nel nuovo quadro europeo (Socrates e Leonardo in
luogo di Erasmus) che si viene delineando e in cui si spera di poter giocare un
ruolo ancor più incisivo. Per inciso, pochi sanno che sono quasi 500 ogni anno
gli studenti pisani che passano periodi di studio all’estero, e altrettanti gli
studenti di altri paesi comunitari che seguono corsi e seminari del nostro
ateneo.
Passo ora alla seconda parte del mio intervento, quella
relativa all’efficienza organizzativa e dunque alle realizzazioni di quest’anno
e alla programmazione di quelle del prossimo anno.
Avevo segnalato, in sede di programma, il cattivo
funzionamento della macchina amministrativa universitaria, pur riconoscendo la
carenza sempre più grave di personale e di risorse. Qualche intervento, anche a
titolo sperimentale, è stato fatto - ho già citato il parziale ridisegno
dell’Ufficio Tecnico e devo citare anche il totale ridisegno in una forma
aderente alle attuali regole della scienza dell’organizzazione aziendale della
segreteria del rettorato - ma molto è ancora in cantiere. Non è facile, e quel
che è più importante non è nemmeno produttivo, operare delle rivoluzioni
organizzative in strutture amministrative complesse che non vedano protagonisti
convinti una parte significativa degli addetti, e tra di essi almeno quei
dirigenti, funzionari e collaboratori che hanno professionalità sicura e
desiderio di gestirla con impegno e responsabilità verso l’istituzione universitaria.
Costoro non sono pochi, per fortuna, e ad essi soprattutto va il mio sentito
ringraziamento per il sostegno che mi hanno dato quest’anno. Non potendoli
nominare tutti personalmente, dico solo il nome di uno di loro, il direttore
amministrativo dott. Giorgio Coluccini.
Scelta questa ottica si è proceduto su due direttive
generali. E’ stato preparato, approvato dagli organi di governo e sarà emanato
a giorni, visto che il Ministero competente ha lasciato passare i termini della
risposta sul merito, il regolamento di applicazione della legge sulla
trasparenza amministrativa. Non è solo una conquista di civiltà quella che
qualunque cittadino che entra in contatto, dall’interno o dall’esterno, con
1’amministrazione universitaria abbia diritto a conoscere esattamente tutti i
passi della procedura che lo riguarda, i tempi massimi previsti e il
funzionario responsabile della procedura o del provvedimento finale. Siamo
soddisfatti, in questo senso, che la nostra università è una delle prime in
Italia a dotarsi di questo regolamento obbligatorio per legge già da qualche
anno. Ma è anche un indispensabile ausilio a chi vuol disegnare, come noi
intendiamo fare, un nuovo schema organizzativo quello del censimento di tutte
le procedure che sono svolte dagli uffici, censimento che deve figurare come
allegato a questo regolamento. Preparare questo censimento ha richiesto un
lavoro massacrante, perché sono parecchie centinaia le procedure, ma adesso
abbiamo davvero lo strumento per operare la riorganizzazione interna; che,
confermo, dovrà sfrondare gli adempimenti inutili o superflui, produrre
regolamenti chiari e semplici, premiare la professionalità, attribuire i
compiti dirigenziali con incarichi a tempo determinato, come previsto dal
nostro nuovo statuto, sottoposti a verifica di efficienza ed efficacia della
gestione.
Ma un’altra importante analisi propedeutica è in
corso e si avvia alla fine, quella della verifica dei carichi di lavoro,
necessaria per legge prima di poter procedere ad organizzare la nuova pianta organica
in autonomia e ad assumere nuovo personale. Calcolo dei carichi di lavoro, con
una metodologia originale che è passata senza alcuna obiezione all’obbligatorio
vaglio ministeriale, e censimento delle procedure sono le due fondamenta su cui
ci apprestiamo a costruire il nuovo sistema organizzativo dell’amministrazione
centrale universitaria.
Mi auguro però che molti colleghi e spero anche molti
studenti abbiano già quest’anno potuto cogliere dei miglioramenti e
sperimentare un funzionamento amministrativo che lentamente ma con chiara
indicazione di tendenza si adegua ai tempi e allo stile di una società moderna
ed evoluta. Mi scuso invece con quanti hanno purtroppo dovuto ancora
sperimentare l’esperienza opposta.
Desidero a questo punto dedicare qualche parola al
rapporto con i sindacati del personale universitario, incontrati regolarmente
ogni mese per le sedute di contrattazione decentrata. Anche qui, credo, pur
nella inevitabile conflittualità che si associa per definizione ad ogni trattativa
sindacale, la parte pubblica e la parte sindacale hanno fatto notevoli passi in
avanti, in ottima collaborazione, nell’ottica comune di migliorare
funzionamento dell’amministrazione e condizioni di lavoro degli operatori. Non
posso elencare tutti gli accordi siglati, ma due mi sembrano particolarmente
significativi nell’ottica del discorso che sto svolgendo: quello che ha portato
all’introduzione generalizzata dell’orario spezzato su cinque giorni (per
intenderci, segreterie e uffici sono aperti anche ogni pomeriggio), avvenuta
con assai maggiore facilità di quanto non appaia per un’analoga norma
attualmente in discussione per la finanziaria 1995, e quella che ha portato a
riaprire il discorso del lavoro incentivato (bloccato da due anni) con una
filosofia completamente nuova e coraggiosa che dovrebbe rompere la spirale
della distribuzione a pioggia e invece premiare significativamente tutti coloro
che sono disposti ad un maggior lavoro con obiettivi e tempi rigorosamente
prefissati.
Una lunga trattativa, conclusa ritengo con successo,
ha portato anche alla regolarizzazione della posizione degli ex lettori, ora
assunti in autonomia con uno specifico contratto a tempo indeterminato per
collaboratori ed esperti linguistici che fissa in modo chiaro compiti, obblighi,
diritti e retribuzione. Si trattava di una spinosa e annosa questione, in cui
l’ateneo ha scelto di prendere più forti impegni economici che nel passato ma
anche di impostarla in modo moderno ed europeo, risolta definitivamente prima
dell’inizio di questo anno accademico con soddisfazione delle parti e, si
spera, con una benefica ricaduta sulla didattica delle lingue per gli studenti
universitari.
Ritorno, con qualche maggior dettaglio, alle
questioni sempre calde e sempre difficili, difficoltà di cui ho già chiarita
l’ovvia origine nella carenza cronica di risorse. Qualche cosa abbiamo fatto in
tal senso, ma non tutto quello che si sperava. Inoltre tanti risultati già
acquisiti sono purtroppo mascherati e quindi non ancora visibili, rallentati da
una lentezza burocratica che non ha eguali e che qualche volta dipende da noi
ma molte altre volte dagli altri enti pubblici cui siamo obbligati a chiedere
pareri o autorizzazioni.
Dei nostri grandi lavori in corso, prosegue bene
quello del recupero del primo edificio della ex Marzotto. Nel gennaio 1994 sono
entrati in funzione e lavorano a pieno regime i laboratori didattici di
informatica e di fisica e un primo gruppo di aule; nello scorso ottobre è stato
consegnato il secondo e ultimo gruppo di aule (in totale sono disponibili 25
aule); nel prossimo luglio dovrebbe essere completato il recupero dell’intero
edificio che ospiterà, oltre alle attività didattiche di matematica, fisica,
informatica e parzialmente di altri corsi di laurea della facoltà di scienze,
anche una parte del dipartimento di fisica. Purtroppo non sono al momento in
vista i finanziamenti straordinari che servirebbero per il recupero degli altri
edifici dell’area industriale dismessa.
Per quanto riguarda l’area Scheibler destinata alla Facoltà
di ingegneria, già nello scorso dicembre il consiglio di amministrazione ha
autorizzato la ripresa dei lavori del primo lotto ma, a tutt’oggi, la catena di
pareri amministrativi e tecnici esterni necessari per concludere questo
intervento non è arrivata alla fine. Ripeto spesso che ci si rende poco conto,
per i non addetti ai lavori, quale lunga trafila debbano seguire i lavori
edilizi universitari. Sono almeno sei gli enti esterni che devono pronunciarsi
(Comune, Regione, Ministero dei Lavori Pubblici, Sovrintendenza alle belle
arti, Vigili del Fuoco, Unità sanitaria locale), ma spesso in casi particolari
sono anche di più. Anche tempi brevi di ogni ente, e spesso non sono tali,
portano ad una distanza temporale di molti mesi tra il momento in cui l’Università
licenzia il progetto e il relativo finanziamento e il momento in cui possano
cominciare i lavori. Da cittadino devo riconoscere che la necessità di
intervento di ogni ente, vista separatamente e in astratto, è sempre o quasi
sempre pienamente condivisibile; da amministratore pubblico devo confessare e
denunciare che la situazione raggiunge troppo spesso caratteristiche
esasperanti. La difesa dei legittimi interessi di tutti i cittadini, sia in
linea di principio che quali finanziatori attraverso il sistema fiscale degli
interventi statali, ha troppo spesso come risultato di gettare discredito sul
medesimo apparato statale quando gli stessi cittadini, che dovrebbero essere
fruitori come utenti delle realizzazioni programmate, sono costretti a lamentarne
ritardi e insufficienze.
In attesa anche la ripresa dei lavori
dell’insediamento di Veterinaria a S. Piero a Grado, pur decisa nella scorsa
primavera. In ambedue i casi, comunque, la ripresa dei lavori non dovrebbe
tardare molto. Per l’area Scheibler, inoltre, confido che nel 1995 potranno
iniziare i lavori per il secondo lotto, già quasi completamente finanziati.
Per tutti i lavori di
manutenzione, quelli che più direttamente toccano il lavoro quotidiano del
personale universitario e degli studenti, a febbraio è stato dato il via ad
interventi per circa 7 miliardi, comprendenti sia il finanziamento 1993 rimasto
bloccato, sia il finanziamento del 1994. Anche qui solo in questi giorni si
stanno aprendo i primi cantieri, con un ritardo che, seppure non totalmente
ascrivibile all’ateneo, è comunque un punto su cui si è iniziato ad intervenire
con un primo ridisegno dell’Ufficio Tecnico ma su cui occorrerà intervenire più
profondamente per ovviare a insopportabili lentezze che permangono, pur nella
dedizione e nella voglia di miglioramento che desidero riconoscere agli addetti
a questo delicato settore. Ma una
delle priorità fondamentali su cui si intende intervenire nel campo delle
realizzazioni edilizie è quella della realizzazione di nuove strutture per la didattica.
Ritornati finalmente in possesso qualche giorno fa della palestra ex CUS di
Piazza dei Cavalieri (e sono veramente in dirittura di arrivo gli atti per
l’inizio dei lavori della nuova palestra CUS in Via del Brennero), saranno
presto iniziati i lavori di realizzazione del polo didattico del centro
storico, già progettato e approvato, che sarà destinato ad aule grandi
necessarie per le esigenze delle affollatissime facoltà del centro storico. Per
circa sei mesi ho poi cercato di reperire aree in cui realizzare un polo di
ateneo per le grandi aule e una grande e funzionale segreteria studenti
unificata. Devo ammettere di non esservi riuscito, anche per le difficoltà in
cui si è dibattuta l’amministrazione comunale fino al suo scioglimento nello
scorso settembre. Qualche passo in avanti però era stato fatto, e mi auguro che
la nuova amministrazione comunale sia al nostro fianco, sia sotto questo
aspetto, sia sotto l’altro, importantissimo ma non strettamente legato
all’università ma all’azienda per il diritto allo studio, di ampliare
rapidamente l’offerta di edilizia specifica, sia pubblica, sia privata, per le
necessità degli studenti universitari non pisani. Questo tema meriterebbe ben
altro risalto, me ne rendo conto, ma il tempo comincia a divenire tiranno.
In attesa di questi interventi di maggiore entità,
comunque, si è provveduto ad un piano di emergenza, del valore di oltre 1.500
milioni compreso il personale e le attrezzature informatiche, per dare servizi
migliori alle segreterie studenti della maggior parte delle facoltà, che
saranno tra poco più di un mese portate dagli edifici inadatti in cui si sono
finora trovate ad un edificio in corso di recupero provvisorio nell’area ex
Marzotto. La lettura automatica dei moduli, l’ampliamento e la velocizzazione
del sistema informativo, regole organizzative più semplici fanno parte di
questo piano di emergenza di cui tra poco gli studenti cominceranno a
beneficiare.
Molti altri sono gli impegni per l’edilizia didattica
che stiamo portando avanti. Solo per fare un esempio visto che riguarda
l’edificio storico centrale dell’università, il palazzo della Sapienza, la
ristrutturazione dei suoi spazi didattici e dei servizi impegnerà nel prossimo
anno cifre dell’ordine del miliardo, pur se molti dei problemi giustamente
segnalati non potranno essere risolti con facilità in un edificio di simile
valore storico. Per l’edilizia che vorrei chiamare dipartimentale, urge la
necessità di impostare il programma di recupero degli edifici universitari che
nella prima metà del 1996 (è un’assicurazione ufficiale del CNR) saranno dal
CNR lasciati liberi. Un intervento però già pronto per essere iniziato, del
costo di circa 500 milioni, è il recupero della palazzina un tempo in affitto
all’IBM per il Dipartimento di Anglistica che così potrà lasciare l’edificio
che ora occupa decisamente manchevole sotto il profilo della sicurezza al
confronto con le centinaia di studenti che lo frequentano.
Temo che queste citazioni, così particolari, possano
far temere che l’ateneo trascuri alcuni settori rispetto ad altri. Non è
assolutamente vero, e tutti i responsabili delle strutture sanno che progetti
che riguardano tutti i dipartimenti e tutte le facoltà sono al nostro studio o
in fase di realizzazione. Certo abbiamo iniziato un tipo di approccio diverso:
ogni lavoro è accuratamente analizzato, spesso in contestazione tra ufficio
tecnico e struttura interessata, per valutarne esattamente costi e benefici,
necessità e urgenza. Solo i lavori che presentano i migliori requisiti in
questi termini e su cui chiediamo che le strutture esprimano in forma ufficiale
il loro parere favorevole, per evitare le costosissime, in tempo e denaro,
modifiche in corso d’opera, sono portati in fase di realizzazione, purtroppo
sempre compatibilmente con le scarse risorse.
Spero anche che possano veder la luce altre
realizzazioni che sono allo studio riguardanti il mondo studentesco ma non
strettamente le attività didattiche. Vorrei che l’ateneo potesse offrire a
tutti gli studenti, quasi come dono e ricordo del 650esimo anniversario, un
primo centro studentesco polivalente, dove essi possano incontrarsi e riunirsi
e dove possano aver sede tutti i gruppi organizzati con un minimo di supporto
logistico (ricordo che lo statuto prevede come organo centrale di governo, con
specifiche competenze, il consiglio degli studenti). Una soluzione è stata già
intravista e si spera si possa concretizzare nel 1995.
Pur nella sua assoluta limitatezza, vorrei anche
citare per la sua importanza sociale ed emblematica di un atteggiamento di
apertura e collaborazione che deve contrassegnare ogni ateneo (mi è molto
gradito ricordare i bellissimi interventi di Lepenies e Cacciari durante il
convegno europeo), un’iniziativa già assunta riguardante il sostegno ai nostri studenti
extra-comunitari e una che si vorrebbe assumere riguardante uno specifico
centro di accoglienza per questi giovani che arrivano spesso privi di qualunque
risorsa immediata che non siano quelle per iscriversi all’università.
Visto che il discorso continua ad incentrarsi sulla
didattica, vorrei anche ricordare altre iniziative andate in porto quest’anno.
E’ stato costituito in febbraio l’Osservatorio per la qualità della vita
studentesca che ha già prodotto importanti documenti (ad esempio sulla condizione
abitativa degli studenti) e verificato in dibattito alcuni dei progetti
dell’ateneo, con una forte intensità di partecipazione sia della componente
studentesca che di quella docente. E’ stato varato il programma per il lavoro
part-time degli studenti, un importante intervento di diritto allo studio, in
quanto riservato a studenti capaci e non abbienti, ma anche un’importante
occasione di contatto diretto e di collaborazione lavorativa tra il mondo
studentesco e l’organizzazione universitaria. Inoltre l’Università di Pisa ha
chiesto al Ministero della Difesa di poter convenzionarsi per l’utilizzazione
nelle sue strutture, per i fini previsti dalla legge, degli obiettori di
coscienza. E’ partito infine il piano bibliotecario di ateneo e il regolamento
dei centri di servizi bibliotecari che dovrebbe far sentire i suoi positivi
riflessi sia sul piano della didattica, sia su quello della ricerca, sia su
quello dell’organizzazione bibliotecaria accorpando i troppi poli bibliotecari
oggi esistenti. Si tratta anche qui di un adempimento statutario anticipato,
visto che lo statuto esplicitamente regola il sistema bibliotecario di ateneo.
Ma la didattica ha come scopo fondamentale quello di
portare le nostre matricole alla laurea o al diploma. Visione assai semplicistica
e non certo accettabile in un’ottica di rapporto tra didattica e ricerca quale
quella delineata da Guido Paduano nel suo intervento al convegno europeo, ma
pur sempre indicativa nella sua fattualità e ahimè nella sua mancata
realizzazione per una quota notevole di matricole. Però desidero segnalare che
la quota di insuccessi va diminuendo, anche se con lentezza. Per i laureati del
1991/92 si attesta attorno al 37%, per quelli del 1992/93 supera di poco il
38%; cifre comunque più alte di quelle spesso citate del 30% di anni passati.
Un altro dato da segnalare è quello della
diminuzione, quest’anno più pronunciata, del numero di matricole. Si sono
immatricolati quest’anno 8551 studenti contro i 9526 dell’anno scorso, con una
diminuzione del 10%. Non si tratta di un dato preoccupante, per chi ha sempre
temuto la crescita incontrollata e lo sfondamento verso il falso traguardo dei
mega-atenei. Tra le cause vi è certo quella dei primi arrivi all’università
delle classi di anni in cui la denatalità ha cominciato a far sentire i suoi
effetti. Ma non si può trascurare che, per una università come la nostra che ha
una forte quota di studenti fuori sede, la negativa congiuntura economica
nazionale del 1992 e del 1993, ancora ampiamente perdurante in amplissime regioni
del Paese, può aver costretto o spinto molte famiglie a rinunciare ad iscrivere
i loro figlioli ad università lontane. Infine può aver giocato un certo ruolo
l’accento forte dato sui mezzi di comunicazione di massa alla variazione in
aumento delle tasse studentesche, che, anche se spesso assai più limitata di
quanto si creda o addirittura di segno contrario per una maggiore equità
ottenuta nella tassazione con il regime di autonomia, può aver convinto gli
studenti meno abbienti e meno motivati a non iscriversi all’università.
Però è da segnalare che in tale complessiva
diminuzione, sono invece in aumento gli immatricolati ai corsi di diploma, o di
laurea breve come si usa dire, che, sia pure su numeri ancora molto bassi,
aumentano del 18%. E tra gli iscritti ai corsi di laurea è evidente la più
pronunciata diminuzione di quasi tutti i corsi che hanno segnalato difficoltà
logistiche dovute all’eccessivo numero di matricole. Vorrei che questi segni
potessero essere confermati in futuro, quale segnale di una maggiore attenzione
di tutti gli studenti alle proprie scelte in un panorama di offerte formati ve
che si andrà rapidamente ampliando, soprattutto per le lauree brevi, e in cui i
dati logistici e occupazionali, senza necessità quindi di interventi regolatori
all’inizio come il numero chiuso, possano ricevere la corretta valutazione di
tutti gli interessati. A questo gioverà il programma di informazione a più
stadi di complessità e di orientamento pre-universitario che l’ateneo dovrà
varare nel 1995. A questa espansione dell’offerta formativa sono collegate
anche le recenti iniziative che prevedono lo svolgimento di parti di corsi di
diploma o di laurea, oltre che a Pisa, anche in sedi del bacino naturale del
nostro ateneo. L’uso della parola “decentramento” per questa espansione, mirata
ad un miglior contatto con il mondo del lavoro per i segmenti
professionalizzanti finali di alcuni curricula, ha causato qualche equivoco,
perché tutti sanno che l’ateneo pisano ha scelto, e conferma tale scelta, di
non istituire né di trasferire corsi di laurea o di diploma in altre sedi.
L’ultimo numero appena pubblicato del Notiziario dell’Università si apre con un
mio intervento, già apparso sulla stampa cittadina, in cui questo problema
viene trattato in maggiore estensione di quanto non si possa e non si debba
fare in questa occasione.
Ma le attività istituzionali universitarie sono due:
la didattica, cui ho dedicato gli ultimi minuti, e la ricerca, alla quale
adesso passo, anche perché risulta abbastanza legata alla terza e ultima parte
del mio intervento, quella relativa al ruolo che l’Università di Pisa intende
giocare nel sistema universitario nazionale e comunitario. La parola d’ordine è
qualità, qualità nella didattica, qualità nella ricerca, qualità nei servizi; il
tutto per poter conservare quel patrimonio di credibilità e di fama accumulato
dal nostro ateneo nella sua lunga storia, ancor per fortuna abbastanza integro
e fruttuoso, che ne dovrebbe fare un polo di eccellenza nel variegato e
competitivo mondo universitario.
Sarebbe davvero impossibile descrivere anche
minimamente l’attività di ricerca di un ateneo che comprende circa 500
professori ordinari, circa 650 professori associati e circa 550 ricercatori, e
alla quale collabora anche una parte del personale tecnico-amministrativo pari
in totale a circa 1700 unità. Devo dire che in quest’anno di celebrazione del
650esimo anniversario, oltre che mio primo anno di rettorato, ho avuto modo di
entrare in contatto sia per i numerosissimi convegni organizzati dai nostri
colleghi, sia per le visite di conoscenza fatte a dipartimenti e istituti, con
moltissime realtà scientifiche di primissimo rango e ne ho ricavato una ancor
più alta valutazione del nostro ateneo, spesso più conosciuto ed apprezzato
fuori che non al suo interno. Valutazione che quasi impaurisce per la
delicatezza del compito affidatomi (tutti sappiamo quanto è delicata una
struttura di ricerca, che impiega lustri per crescere e che può essere
distrutta in pochi anni) e che mi impegna ad una ancor maggiore responsabilità.
Mi sia consentito ripescare dalla mia memoria, pur
conscio che ogni scelta potrebbe risultare falsata e me ne scuso in anticipo,
due convegni di quest’anno appena concluso che hanno celebrato risultati
scientifici di grande rilevanza. Nella scorsa primavera, in un incontro in aula
magna storica e con un panorama inusuale per questi appuntamenti (tanti
studenti accoccolati per terra davanti al tavolo dell’oratore, un senso di
partecipazione e quasi di tifo sportivo), Giorgio Bellettini e i suoi
collaboratori hanno presentato l’avvenuta evidenza sperimentale dell’ultima
particella fondamentale mancante, il quark top. Una scoperta da Nobel, occorre
dirlo senza esorcismi, per la quale i responsabili del gruppo trinazionale di
ricerca, tra cui appunto Bellettini per l’Italia, risultano già essere stati
presi in considerazione dalla commissione del premio Nobel. Se questo
riconoscimento, come tutti ci auguriamo, dovesse davvero essere concesso nei
prossimi anni, si tratterebbe del terzo premio Nobel per la fisica di
formazione pisana e del primo interamente pisano.
Nello scorso ottobre, invece, la nostra egittologa
Edda Bresciani ha presentato in questa medesima sala dove ci troviamo la
scoperta ad opera del suo gruppo di un’importantissima tomba nel Fayum e il
bellissimo progetto di recupero che la nostra università ha in parte già
finanziato con parte del contributo ottenuto dalla Regione Toscana per il
650esimo anniversario. La presentazione della scoperta, arricchita di una
mostra multimediale con eccezionali supporti informatici per la ricostruzione
virtuale della tomba al momento in macerie, è rimasta impressa in chi ha avuto
la fortuna di assistervi ed è contenuta in una videocassetta disponibile in
rettorato.
L’imponente attività di ricerca degli studiosi
dell’ateneo pisano si unisce a quella delle altre due scuole superiori (la
Scuola Normale e la Scuola S. Anna), della grande area di ricerca del CNR,
della prestigiosa sezione pisana dell’INFN, di altri laboratori di ricerca di
enti pubblici e privati. Questa città, dunque, è ricca di un sistema
localizzato di ricerca quasi senza eguali in Italia e forse anche in Europa,
quasi tremila ricercatori in una stessa città di poco meno di centomila
abitanti. Questo sistema di ricerca ha l’opportunità e, in certo senso, il
dovere di collaborare con il sistema produttivo del suo bacino naturale che si
estende lungo tutta la costa tirrenica della Toscana, da Grosseto fino alla
Spezia.
Ed ecco dunque che, oltre alla prossima conferma
dell’importante consorzio Pisa Ricerche per i prossimi dieci anni, tramite il
quale l’ateneo pisano intende partecipare alla società per il parco
scientifico-tecnologico della Toscana occidentale, l’Università di Pisa ha
stipulato una convenzione con l’associazione industriali della provincia di
Pisa, già estesa anche a quella di Livorno ed estendibile senza alcuna
particolare difficoltà, anzi con interesse per gli attuali convenzionati, alle
associazioni industriali di Lucca, Massa Carrara, Grosseto, La Spezia). Altre
convenzioni, su temi più specifici di ricerca, sono state parimenti stipulate,
o sono stati firmati i relativi protocolli di intesa per la costituzione di
opportuni consorzi con enti territoriali e con imprese interessate
all’innovazione tecnologica.
Una simile attività di ricerca richiede anche una
serie di servizi di alta tecnologia. Prendo ad unico esempio la rete
informatica di ateneo, definitivamente decollata con il nome SERRA, collegata
ad Internet, che fornisce una quantità sempre crescente di opportunità informative
per un numero rapidissimamente crescenti di utenti universitari anche al di
fuori dei tradizionali bacini delle facoltà di scienze e di ingegneria. Nel
corso del 1995 dovrebbe essere completata la disponibilità presso tutti i poli
universitari pisani di un attacco alla rete SERRA, che si è creata una certa
notorietà anche a livello internazionale a giudicare dalle migliaia di accessi
al giorno che vengono da tutti i continenti e dagli inviti a convegni
internazionali di esperti di reti per i nostri esperti e addirittura per nostri
studenti conosciuti tramite questa rete.
Ho lasciato fuori finora da questa relazione una
attività particolarissima, quella dell’assistenza sanitaria, che ha un
inscindibile legame con le attività istituzionali della facoltà medica e che
non a caso è stata specificamente inserita nell’articolo 6 del nuovo statuto
subito dopo gli articoli sulle attività istituzionali. Anche questo settore è
stato soggetto ad una vera “rivoluzione” con l’istituzione regionale delle
aziende ospedaliere universitarie e l’applicazione ancora molto parziale della
riforma della sanità contenuta nei Decreti Legislativi 502/92 e 517/93. Mi
limito qui a dire che quest’argomento è stato seguito con particolare
attenzione sia in sede locale che regionale, per definire sia gli aspetti della
nuova convenzione costitutiva dell’azienda mista, sia gli intricati processi
del periodo transitorio come le innumerevoli pendenze convenzionali aperte.
Mi avvio alla conclusione, pur rammaricandomi di aver
dovuto lasciare tanti aspetti importanti in ombra. E vorrei concludere
agganciandomi al convegno europeo che stamattina si è concluso e che abbiamo
avuto l’onore e il piacere di ospitare. Spero che dalle mie parole si sia
percepita in sottofondo la dimensione culturale e dunque europea che il nostro
ateneo ha scelto e ha come programma fondamentale. Ma, come dicevo
nell’indirizzo inaugurale del convegno, la dimensione europea vuol dire anche
individuare le radici comuni della civiltà universitaria europea. E tra di esse
vi è certo il binomio tra libertà e ragione, tra metodo e dubbio, tra unità da
perseguire e diversità da mantenere, tra immaginazione e astrazione e dura
verifica sperimentale che mi piace far risalire al pisano Galilei, in un vagare
alla ricerca di improbabili paradisi razionali sempre perduti che è dell’Ulisse
omerico che sta alle origini della nostra civiltà. E in questo vagare,
l’Università è la sede primaria del dibattito, del pluralismo, dell’alterità,
della varietà, del paradosso e del dilemma fedeli compagni della nostra
razionalità. Ripeto le già citate parole di Milton: al lume della loro assidua
lucerna, meditano e indagano, volgendo e rivolgendo le nuove idee e i nuovi
concetti, lasciandosi guidare dalla forza convincente della ragione.
Con l’auspicio che il soggetto di questa frase
possiamo essere noi, professori e studenti, dichiaro ufficialmente e
solennemente aperto l’anno accademico 1994-95 dell’Università di Pisa, 651esimo
dalla fondazione.
Da: Annuario dell’Università degli studi di Pisa per gli
anni accademici 1990-1995.