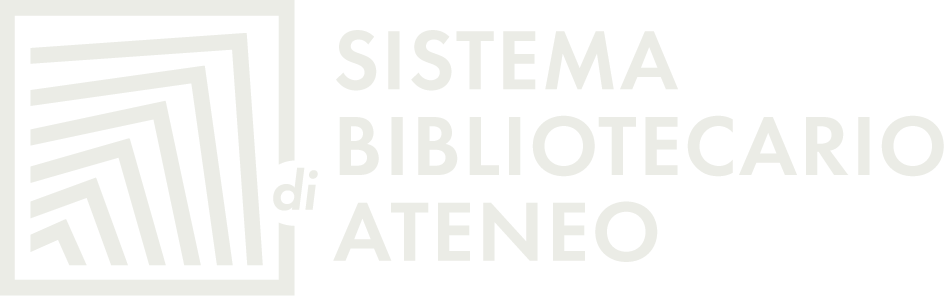Inaugurazione dell’anno
accademico 1995-96, 652° dalla fondazione
Relazione del Rettore,
prof. Luciano Modica
Signor
Ministro per l’Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica prof. Salvini,
Sua Eminenza Arcivescovo di Pisa mons. Plotti, Sua Eccellenza Signor Prefetto
di Pisa dott. Lococciolo, Signor Sindaco di Pisa prof. Floriani, Signor
Presidente della Provincia di Pisa dott. Nunes, Autorità tutte civili e
militari, Signori Direttori della Scuola Normale e della Scuola S. Anna, cari
colleghi docenti, cari studenti, cari dirigenti, funzionari e collaboratori
tecnico-amministrativi, gentili signore e signori,
Vi
ringrazio vivamente di essere intervenuti così numerosi a questa cerimonia di
inaugurazione dell’anno accademico che anno dopo anno rappresenta il momento
solenne e l’occasione stimolante per descrivere l’attività dell’Università di
Pisa nell’anno accademico appena trascorso e per illustrare le prospettive
dell’anno che inizia, alla luce dei successi colti ma anche dei ritardi o
talora degli insuccessi che abbiamo dovuto registrare rispetto al programma che
avevo proposto ai colleghi prima della mia elezione a rettore nel dicembre di
due anni fa e al discorso inaugurale dell’anno scorso.
E’
anche il momento di fare un primo bilancio del mio rettorato, seppure non
definitivo. Il mio mandato scade il prossimo 31 ottobre e quindi nella tarda
primavera del 1996 si terranno le elezioni, per il rettore intendo, le prime
che si svolgeranno secondo il nuovo statuto. Voteranno quindi per la prima
volta, insieme con tutti i professori, anche tutti i ricercatori ed una quota
piccola ma significativa di rappresentanti degli studenti e del personale
tecnico-amministrativo. Dai problemi e dai risultati nell’applicazione del
nuovo statuto desidero allora incominciare, come già l’anno scorso, il mio
discorso.
Innanzitutto
si è completata, nei tempi previsti, la costituzione degli organi di governo
secondo il dettato statutario. Il senato accademico, che mi siede accanto e di
cui colgo l’occasione di ringraziare i componenti per il lavoro che svolgono e
per la collaborazione intelligente e amichevole che mi offrono, già da un anno
governa l’ateneo nella sua nuova composizione, che comprende, oltre al
prorettore vicario, al direttore amministrativo e agli undici presidi di
facoltà, anche dodici docenti in rappresentanza dei dipartimenti raggruppati in
sei settori culturali, quattro studenti e due rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo. Più però che la composizione, sono nuovi molti dei
compiti che il senato accademico ha avuto assegnati dallo statuto, per di più
in una fase complessa ma affascinante quale quella dell’applicazione delle
leggi che hanno portato gli atenei ad una gestione autonoma dalle linee ben più
ampie che quelle che molti si attendevano o prevedevano. Anzi in una fase in
cui le università si stanno conquistando margini di autonomia davvero
rimarchevoli anche nel contesto europeo e internazionale, con una grande
determinazione, che talora sconfina nell’aggressività, ma anche con grande
responsabilità e senso istituzionale, in una sfida per il rinnovamento della
pubblica amministrazione che le vede impegnate in prima fila, e con grande
fantasia e concretezza.
A
questo proposito mi è capitato spesso di dire che un punto privilegiato di
osservazione della pubblica amministrazione in Italia e delle sue possibilità
effettive di riforma dall’interno è stato costituito negli ultimi due anni
dalla Conferenza dei Rettori. Questa ha assunto un ruolo cruciale sia nei
confronti del Ministero - un ruolo propositivo e collaborativo ma anche, quando
necessario, negoziale e spigoloso - sia nei confronti di tutti gli atenei, come
luogo di scambio di esperienze manageriali e di acquisizione attiva, secondo un
modello tipicamente anglosassone, di best practices gestionali piuttosto
che di recepimento passivo e spesso irritato di normative esterne. Devo
riconoscere che, in particolare, far parte del comitato di presidenza della
Conferenza dei Rettori mi ha da un lato fornito spunti preziosi per la mia
attività di rettore e da un altro ha consolidato la mia visione dell’università
e della sua autonomia, facendomi sentire parte di un’esperienza civile di
respiro nazionale e di interesse strategico.
Se
mi è concesso un paragone certamente discutibile ma a mio parere accettabile
nei limiti delle ovvie riduzioni di scala e di spettro di argomenti, i rettori
italiani si sono trovati nella posizione di molti sindaci, chiamati entrambi
dall’opinione e dalle forti attese positive di chi li ha eletti a gestire un
forte rinnovamento delle rispettive istituzioni senza peraltro poter contare su
maggiori risorse e dovendo fare i conti con strutture amministrative molto
spesso volenterose ma non sempre preparate all’improvviso cambiamento. E come è
avvenuto tra i sindaci, è stato fondamentale poter contare su uno spazio, anche
non istituzionalizzato, di dibattito e di sostegno reciproco.
Tornando
all’applicazione dello statuto per gli organi centrali di governo, lo scorso
mese si sono svolte le elezioni e dal primo novembre è già regolarmente
insediato anche il nuovo consiglio di amministrazione, completamente interno
all’ateneo e molto più ridotto in numero dei componenti del precedente anche se
grosso modo ne rispecchia le componenti rappresentative. Resterà in carica
quattro anni e, a differenza del senato, non ha molto mutato le sue competenze
generali, anche se ne sono accentuate le caratteristiche tecniche di organo
gestionale a fronte di un senato che traccia tutte le linee politiche e che ha
responsabilità di tutte le ripartizioni tra le strutture dell’ateneo di voci di
bilancio relative alla didattica e alla ricerca.
Tra
i membri del consiglio di amministrazione siede adesso un rappresentante
nominato dal collegio dei direttori di dipartimento, un altro organo previsto
dallo statuto che è recentemente passato dalla fase di esistenza sperimentale
alla sua costituzione ufficiale.
Infine
è stato costituito il consiglio degli studenti che riunisce tutti gli studenti
eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e in altri
consigli di gestione riguardanti il diritto allo studio e lo sport
universitario, e infine nei consigli di facoltà. Lo statuto ha voluto questo
consiglio (altrove chiamato senato degli studenti) tra gli organi centrali di
governo, definendolo come organo autonomo di organizzazione e coordinamento
degli studenti, attribuendo gli ampi compiti consultivi e propositivi, la
capacità deliberativa in merito alla ripartizione dei finanziamenti destinati
alle attività formative complementari autogestite dagli studenti (cultura e
scambi culturali, tempo libero, sport), e infine garantendogli supporto
logistico e finanziario per il suo funzionamento.
Per
portare in questa cerimonia inaugurale la voce della componente studentesca e
per testimoniare l’importanza centrale del ruolo assegnato dallo statuto al
consiglio degli studenti, seguendo un uso che è di molti paesi europei e anche,
recentemente, di alcune università italiane, alla fine di questo discorso vi
sarà un intervento dello studente Alberto Demagistris, che è il presidente del
consiglio degli studenti e che certamente includerà nel suo indirizzo
inaugurale anche qualche ulteriore notazione su questi primi mesi di
funzionamento del consiglio degli studenti, che dunque qui ometto.
Dicevo
prima dei nuovi compiti del senato. Ecco dunque che il senato accademico ha
affrontato nello scorso anno il difficile problema della ripartizione e del
riequilibrio tra le facoltà delle risorse finanziarie da destinare
all’assunzione di nuovo personale docente, provenienti dalle disponibilità
budgetarie createsi per pensionamenti, dimissioni, trasferimenti, passaggi ad
altro molo et cetera di professori e ricercatori nell’anno 1994. Per la prima
volta, sia pure su una quota piccolissima del budget per personale docente di ogni
facoltà, si è tentato e si è riusciti a determinare l’assegnazione delle
risorse in base a parametri, certo discutibili e da approfondire, ma pur sempre
oggettivi. Si deve al senso di responsabilità di tutti i membri del senato se
la procedura, pur riducendo la disponibilità di alcune facoltà a favore di
altre, è arrivata in porto con unanime consenso, segnando certamente un momento
di svolta nella gestione dell’ateneo. Molte altre università, segnatamente
quelle più vicine alla nostra per tradizione e tipologia, hanno seguito un
percorso analogo, ed è stato molto interessante poter confrontare le soluzioni
trovate, nessuna eguale all’altra ma tutte simili per impostazione e scelte
fondamentali. Gran parte di tali risorse assegnate alle facoltà sono andate
alla richiesta di copertura per concorso di oltre 70 nuovi posti di associato,
del quale attendiamo il bando.
Colgo
l’occasione per intervenire su un tema che il Ministro Salvini conosce bene e
sul quale la stampa nazionale è intervenuta recentemente con vigore. Pur
essendo da respingere l’idea di una “cattedropoli” (chi poteva prevedere che il
neologismo giornalistico “tangentopoli” creato per Milano doveva avere così
curiose e assurde estensioni linguistiche!) della quale mi sembra manchino
molti presupposti e comunque quello della comprensione dei meccanismi di
avanzamento nelle carriere universitarie di tutti i paesi del mondo, non si può
negare che l’attuale sistema concorsuale necessiti decisamente di una riforma,
sia per individuare finalmente norme chiare e trasparenti, sia per adeguarsi al
nuovo modello di autonomia gestionale degli atenei, i quali non possono
attendere, se non con gravi costi organizzativi e anche finanziari,
l’espletamento ogni quattro o cinque anni di farraginosi concorsi nazionali per
coprire le loro posizioni docenti che si siano rese vacanti o che si intenda
coprire ex novo, sui propri bilanci, per una migliore offerta formativa.
Do
volentieri atto al Ministro Salvini che il suo disegno di legge andava
decisamente in questa direzione; purtroppo i tempi parlamentari sono diventati
lunghissimi, anche se proprio l’altro ieri la Conferenza dei Rettori ha appreso
che si è forse aperto uno spazio di accordo su un testo che fondamentalmente
segue, anche se non proprio molto da vicino, il testo del disegno di legge
governativo. Nel frattempo è pronto sul tavolo del Ministro un bando di
concorso che darebbe spazio al reclutamento di oltre 2.500 nuovi professori
associati e, subito dopo, alla possibilità di ricoprire con forze più giovani i
posti di quei ricercatori che siano divenuti associati.
E’
molto difficile dire quale sia la tattica ottimale per ottenere, come quasi
tutto il mondo universitario chiede, sia nuove norme concorsuali che una rapida
emanazione del bando di concorso. La mia opinione personale, condivisa peraltro
da molti colleghi rettori, professori e ricercatori, è che, nel caso in cui il
Parlamento non riesca ad approvare molto rapidamente una legge al riguardo,
sarebbe comunque opportuno bandire il concorso per professore associato anche
con le norme previste dalle leggi vigenti. E’ infatti un valore troppo alto per
le università italiane quello di riaprire e sperabilmente rendere regolare,
come prescrive la legge, il reclutamento sia nella fascia dei professori che in
quella dei ricercatori, anche perché un costo pesantissimo, ancora forse non
ben valutato nella sua gravità, lo ha avuto il sostanziale blocco del
reclutamento nei confronti di un’intera generazione dei giovani
intellettualmente più dotati. Inutile dire che i comportamenti concorsuali
illeciti o scorretti, possibili peraltro con qualsivoglia regola concorsuale in
un sistema che deve rimanere cooptativo perché tale è nel sistema universitario
internazionale, devono essere perseguiti con molta determinazione nelle sedi
competenti e comunque dovrebbero essere isolati e denunciati con decisione
nell’ambito di una auspicabile rinnovata etica civile della responsabilità
scientifica personale dei docenti universitari.
Tornando
ai problemi di ripartizione delle risorse, ancor più interessante è stato il
confronto con altri paesi europei in seno alla conferenza europei dei rettori
su questo medesimo tema. Nonostante i toni rassegnati e vagamente
autolesionistici di molta stampa italiana, si può dire con sicurezza che tra le
università europee, comprese le italiane, vi è una sostanziale comunanza e
somiglianza di problemi, così come vi è un largo accordo sulle soluzioni, pur
nelle specificità nazionali. Il punto di divario reale per il nostro sistema
universitario è invece da una parte quello dell’insufficiente finanziamento
statale della ricerca e delle realizzazioni strutturali (mentre sul lato del
finanziamento di gestione non si registra un analogo divario a parità di costo
della vita), dall’altra parte quello della terribile lentezza decisionale e
operativa per gli interventi di innovazione strutturale, sia legislativi, ove
necessari, che edilizi. L’autonomia e l’agilità universitarie qui si scontrano
con un sistema nazionale che, soprattutto in questo momento politico, non
riesce a produrre leggi e non riesce a semplificare le procedure, a causa
soprattutto di un sistema di controlli e di vincoli a priori che, pur nella sua
sostanziale e dimostrata inefficacia, non è stato sostituito da un vero
coraggioso controllo gestionale a posteriori.
Controllo
gestionale che invece è alla base di due degli importanti nuovi regolamenti di
ateneo, quello sulle attività amministrative, finanziarie e contabili ormai in
dirittura di arrivo (l’approvazione finale del consiglio di amministrazione è
prevedibile per la seduta che si terrà il prossimo Mercoledì 29 novembre dopo
che il senato accademico ha già dato il suo parere favorevole) e quello già
approvato sull’organizzazione degli uffici amministrativi centrali.
Il
primo dei due è in ritardo di circa sei mesi rispetto alle scadenze statutarie,
ma la complessità dell’articolato e delle disposizioni e la lunghezza dell’iter
di approvazione credo che possano far comprendere, se non giustificare, questo
ritardo, che si è verificato nonostante l’impegno straordinario dei prorettori
Massera e Miolo Vitali che con me hanno preparato il testo sottoposto agli
organi di governo. Non è qui la sede, anche per ragioni di tempo, in cui si
possa descrivere l’impostazione generale del nuovo regolamento di contabilità,
salvo che appunto dicendo che quell’autonomia che le università hanno ottenuto
dal Ministero qui si riverbera nell’alto tasso di autonomia gestionale di
dipartimenti e facoltà, oltre che degli uffici dirigenziali
dell’amministrazione centrale dell’ateneo. Un sistema di controlli e di
valutazione completa questo disegno strategico di decentramento delle decisioni
e delle responsabilità. Speriamo che il parere del Ministero, dovuto per legge
prima che il rettore possa emanare questo regolamento, pervenga il più
rapidamente possibile, in modo che già nei primi mesi del 1996 si possa
iniziare ad applicarlo. L’applicazione non potrà peraltro che essere graduale,
per la necessità di predisporre gli strumenti operativi, in particolare quelli
informatici, e di aggiornare il personale, secondo un ciclo di corsi di
aggiornamento già predisposto.
Il
secondo regolamento, di tipo più interno e di prossima emanazione, regolamenta
invece in modo nuovo il modello organizzativo dell’amministrazione centrale dell’ateneo.
L’idea di fondo è quella voluta dalla legge di separare le funzioni di scelta
politica e di gestione amministrativa, pur tenendo conto della peculiarità
dell’università tra le istituzioni pubbliche e della figura del rettore quale
suo massimo organo di governo. I dirigenti hanno quindi un budget da
amministrare in base alle scelte politiche degli organi di governo e ad essi
rispondono, anche personalmente, in termini di assolvimento della missione
ricevuta e di valutazione della qualità del prodotto fornito. Negli uffici
amministrativi centrali un unico grande dipartimento suddiviso in settori si
occuperà di tutte le attività istituzionali cioè di ricerca e di didattica,
compresa la gestione del personale docente e delle carriere degli studenti.
Tutti gli altri uffici diventano servizi trasversali di supporto alle attività
istituzionali, naturalmente di importanza fondamentale ma senza poteri di
normazione e controllo sugli altri uffici e sulle strutture didattiche, di
ricerca e di servizio. Tutto il modello è orientato al prodotto da fornire più
che alla procedura di costruzione del prodotto; conseguentemente la
responsabilità si sposta dalla verifica della procedura alla qualità del
servizio offerto agli studenti e alle attività istituzionali. Anche in questo
caso l’applicazione del regolamento necessiterà di gradualità e aggiornamento
del personale.
Altri
regolamenti di ambito più limitato (ad esempio per i professori a contratto e
per i centri bibliotecari) sono stati già approvati: la loro collazione formerà
poi il regolamento generale di ateneo per il quale i tempi di sei mesi previsti
dallo statuto appaiono davvero ristretti. In leggero ritardo anche il
regolamento didattico di ateneo, in questo momento nella fase di elaborazione
da parte della commissione didattica di ateneo. L’emanazione del regolamento
didattico è prevedibile per il prossimo mese di aprile, quella del regolamento
generale di ateneo alla fine di quest’anno accademico.
L’anno
accademico trascorso ha visto dunque, come certamente quello che verrà, un
forte impegno in campo regolamentare, in attuazione del resto dello statuto che
prevede che le sue stesse finalità siano realizzate attraverso lo strumento dei
regolamenti. Un grande equilibrio è richiesto nella stesura di questi importanti
documenti, perché essi devono avere quella struttura tecnica che ne permette
l’applicazione sicura nei multiformi casi che la realtà inevitabilmente
propone, ma insieme devono raggiungere l’obbiettivo di semplificare fin dove
possibile le procedure per evitare che siano percepiti come una nuova forma di
burocratizzazione. Nel mondo universitario non è raro che ogni forma
organizzativa venga talora vissuta in modo negativo, ma non esiste
un’istituzione complessa che possa funzionare senza regole certe, se non
disperdendosi in un’infinità sostanzialmente ingiusta e comunque ingestibile di
microdecisioni. Darsi delle regole per operare in modo trasparente ed
efficiente non significa creare burocrazia ma solo mostrare capacità
gestionale.
Ai
regolamenti di carattere generale dovranno poi aggiungersi quelli che, in
sostanziale autonomia organizzativa, dovranno darsi facoltà, dipartimenti e
altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Con una logica di tipo
sperimentale alcuni sono stati già approvati, altri sono in fase di esame per
l’approvazione; i primi approvati costituiranno poi un’indicazione operativa,
anche se non vincolante, per tutti gli altri.
Devo
riconoscere che, nonostante avessi previsto di farlo, non sono riuscito finora
a predisporre per l’esame e l’approvazione da parte degli organi centrali di
governo né il piano pluriennale di sviluppo, né il programma annuale di
attività, ambedue importanti documenti programmatori previsti dallo statuto.
Penso di poter predisporre il programma annuale nelle prossime settimane, il
piano pluriennale nei prossimi mesi, tenendo conto che il bilancio di
previsione del 1996 è stato già predisposto dalla competente commissione e
andrà in approvazione nel mese di dicembre (il programma annuale di attività
dovrebbe stare alla base del bilancio di previsione, ma vorrà dire che per
quest’anno in modo sperimentale si procederà nel senso opposto) e che nel
prossimo marzo, a livello nazionale, dovranno essere iniziate le procedure per
il piano triennale di sviluppo 1997/1999, anche se purtroppo dobbiamo
registrare come atenei italiani il fortissimo ritardo del piano 1994/1996
ancora non emanato anche se il decreto ministeriale relativo si trova ormai
presso le commissioni parlamentari per l’ultimo parere richiesto dalla legge.
In
mancanza dunque del programma annuale di attività, mi permetto di anticipare
alcune linee del bilancio preventivo 1996, così come licenziato alla
commissione permanente per il bilancio. Il totale delle entrate disponibili
ammonta a circa 400 miliardi, di cui il 69% (circa 280 miliardi) proviene dai
contributi 1996 del Ministero dell’Università, il 12% dal riaccredito di
disponibilità non spese nel 1995, il 10% dalle tasse e contributi pagati dagli
studenti, il 5% da finanziamenti e contratti non ministeriali per la ricerca.
Un’analisi accurata mostrerebbe come si vada riducendo l’apporto percentuale
dei fondi ministeriali che peraltro aumentano in entità reale, come si mantenga
costante l’apporto degli studenti (del resto non sono state aumentate, anzi
leggermente diminuite, le tasse del 1995/96), come sia in netto aumento
percentuale e assoluto l’apporto dei finanziamenti esterni della ricerca, tra i
quali spiccano quelli della Unione Europea in cui il nostro ateneo ha ottenuto
lusinghiere performances su scala italiana, come ha dimostrato un
recente intervento dell’agenzia APRE nel convegno-presentazione di programmi
europei in campo biomedico tenutosi a Pisa lo scorso ottobre. Evidenziare il
riaccredito delle disponibilità vuole segnalare da un lato lo sforzo fatto per
recuperare sul bilancio le partite di residui che mi permetto scherzosamente di
chiamare “smarriti”, dall’altro il primo segno del passaggio da un bilancio
fatto per competenza secondo il tradizionale modello statale a quello nuovo che
avrà una forma di cassa più tipicamente aziendale.
Se
si passa al quadro delle uscite, si troverà che i 400 miliardi a pareggio sono
utilizzati per il 63% (256 miliardi) per stipendi e oneri accessori al
personale docente (2/3 del totale) e non docente (1/3 del totale), per l’11%
per l’edilizia sia didattica che dipartimentale, per l’8% per la ricerca, per
il 6% per borse di studio post-laurea, per il 4% per il funzionamento delle
strutture didattiche, di ricerca e di servizio (facoltà, dipartimenti, centri
bibliotecari, etc.), per il 4% per le spese dell’amministrazione centrale e per
i servizi generali (ENEL, pulizie, etc.), per il 3% per borse di studio e altre
attività (orientamento, contratti part-time, etc.) per studenti. Un’analisi
delle scelte compiute mostrerebbe un aumento dei budget di facoltà e
dipartimenti da 14 a 16 miliardi e anche un aumento delle spese per la ricerca
su fondi di ateneo che passa dai 6 miliardi della antica quota ministeriale del
cosiddetto 60% ai 9 miliardi del 1996 sul bilancio autonomo. Lo sforzo
sostenuto è notevole; speriamo che a questi investimenti possa corrispondere un
aumento della qualità della ricerca svolta e della intera vita universitaria:
questo aumento in larga misura dipende ormai dalle capacità di gestione dei
responsabili delle ricerche e delle strutture universitarie.
Desidero
ora passare ai problemi relativi agli studenti e alla didattica, cui un lavoro
incessante è stato dedicato dal prorettore Denti. Nel 1994/95 è andato in
porto, non senza difficoltà, il nuovo sistema di tassazione, oneroso dal punto
di vista organizzativo perché fortemente personalizzato, ma appunto per questo
assai più equo nella ripartizione del carico contributivo. Siamo soddisfatti
del risultato, anche se certamente si sono verificati alcuni ritardi e alcuni
intralci che hanno causato disagio agli studenti. Circa 30.000 studenti hanno
presentato domanda di riduzione per ragioni di merito o di reddito, ma solo
20.000 hanno davvero avuto ridotta la contribuzione. La tassa media è stata
circa di L. 900.000. E’ attualmente in corso la verifica su un campione del 2%
delle autocertificazioni di coloro che hanno usufruito di una riduzione,
secondo quanto previsto dal regolamento delle tasse e contributi. L’obbligo di
aggiornare, per poter procedere al calcolo dei parametri relativi di merito, le
posizioni di carriera di tutti gli studenti è costato un formidabile lavoro ma
ci ha permesso di avere un quadro assai più preciso della situazione. Perfino
il numero di studenti è ora valutabile con maggiore esattezza: sono circa
46.000 gli iscritti dell’anno accademico 1994/95, quindi ben di più della cifra
di 40.000 spesso ripetuta in modo acritico.
Difficile
dire la situazione del 1995/96 perché è ancora possibile immatricolarsi o
iscriversi fino al 3l dicembre e, per i fuori corso, fino al 30 aprile. Pare
abbastanza certa, però, una flessione delle matricole di qualche punto
percentuale, decisamente più pronunciata - ed è un dato interessante su cui
riflettere - in quei corsi di laurea che risultavano più affollati. La
flessione, comune a tutti gli atenei italiani, in parte dipende dalla
denatalità che si cominciava a verificare vent’anni fa e dalla persistente
crisi economica in larghe parti del Paese, in parte forse da un eccesso di
sfiducia che è maturato nella società nei confronti della laurea. Se oggi
laurearsi non vuol purtroppo certo dire trovare un lavoro e subito, è anche
fallace l’opinione abbastanza diffusa che laurearsi non serva o sia addirittura
controproducente per l’inserimento nel mondo del lavoro. Non credo invece che
la flessione dipenda dall’ammontare delle tasse universitarie, visto che l’anno
scorso, in presenza di un limitato aumento medio ma di un forte aumento sui
massimi, abbiamo verificato un leggero incremento di matricole rispetto al
1993/94, mentre quest’anno, a tasse invariate se non in leggera diminuzione per
gli studenti provenienti dalle famiglie più disagiate, si registra una
flessione. Rimane sempre assai limitata la partecipazione ai corsi di diploma,
cioè alle lauree brevi. Un’analisi di questo fenomeno sarebbe opportuna ma
esula purtroppo dai limiti di tempo di questo discorso.
Ma i
problemi degli studenti e della didattica non si possono certo ridurre alle
tasse e contributi da pagare. Innanzitutto non si riesce apparentemente ad
aumentare il flusso percentuale e assoluto dei laureati, che anzi appare
sostanzialmente costante dopo qualche anno di leggero aumento. I docenti e gli
studenti dovrebbero riflettere su queste difficoltà del processo formativo,
addensate chiaramente al primo impatto con l’università, a causa di un
insufficiente orientamento degli studenti ma anche di un’insufficiente
attenzione dei docenti al livello di preparazione degli allievi, e poi
distribuite omogeneamente lungo la carriera per una cronica lentezza degli
studenti nel seguire i tempi, forse troppo impegnativi, dei curricula
ufficiali.
Non
voglio nemmeno tacere, visto che si è recentemente sollevata qualche polemica,
sulla questione dell’impegno didattico dei professori. Gli studenti stessi
hanno affermato che la maggior parte dei professori non è censurabile, anzi
spesso è apprezzabile, da questo punto di vista. Ma questo non esclude che
qualcuno di noi possa impegnarsi meno o possa addirittura venir meno ai suoi doveri
didattici. Non si creda che servano chissà quali nuove leggi e nuovi
regolamenti: il regolamento vigente nell’ateneo sui doveri didattici dei
professori, approvato qualche anno fa e forse sconosciuto a molti studenti (i
professori lo trovano stampato all’interno del registro delle lezioni), sarà
certamente perfettibile al momento dell’emanazione del nuovo regolamento
didattico ma offre comunque sin d’ora le coordinate di riferimento per valutare
l’assolvimento dei doveri didattici dei docenti e l’assegnazione delle
responsabilità del controllo, sostanzialmente pertinenti a presidi di facoltà,
presidenti di corso di laurea o diploma, direttori di dipartimento o istituto.
Il problema è piuttosto un altro. Risulta nell’esperienza comune assai
difficile e raro passare dalla forma della denuncia generica o addirittura
della battuta o del pettegolezzo alla forma della responsabile segnalazione
dell’eventuale abuso a chi ha la responsabilità di sanzionarlo o al rettore
stesso come rappresentante dell’ateneo.
Ma
la valutazione dell’efficacia delle attività formative, che spetta per statuto
al senato accademico, deve andare ben oltre la puntuale verifica dei doveri di
tutti gli attori del processo educativo. Quest’anno ho avuto la fortuna di
partecipare, come responsabile nazionale, ad un progetto pilota della
Commissione Europea sulla valutazione della qualità dell’istruzione
universitaria che ha coinvolto oltre 50 università di 17 diversi paesi europei.
Si è trattato di una sperimentazione molto limitata, ma in vivo, di una
metodologia europea di valutazione della qualità; il prossimo 18 dicembre si
terrà in Spagna la riunione conclusiva e al termine saranno resi pubblici i
rapporti nazionali e quello europeo di sintesi, tesi non a mettere in
graduatoria i percorsi formativi valutati ma bensì a enucleare pregi e difetti
della metodologia proposta.
A
questo progetto, cui spero seguirà un secondo più esteso e perfezionato da
lanciarsi nel prossimo semestre di presidenza italiana della Unione Europea,
corrisponderà nel prossimo anno un progetto italiano coordinato dalla
Conferenza dei Rettori cui spero che il nostro ateneo possa e voglia
partecipare. In ogni caso comunque è urgente - se ne è già accennato in senato
accademico - aprire una riflessione sulla qualità della didattica e sui mezzi
per verificarla e misurarla, tra i quali, come già succede in alcuni
insegnamenti e in alcuni corsi di laurea qui a Pisa, giocheranno un ruolo
importante i questionari di valutazione riempiti dagli studenti.
Parlando
di valutazione merita un accenno il fatto che l’Università di Pisa ha istituito
quest’anno il Nucleo di Valutazione Interna, incaricato, secondo il dettato di
legge, di verificare mediante analisi comparative di costi e rendimenti dedotti
dal bilancio consuntivo 1994 la corretta gestione delle risorse pubbliche e la
produttività della ricerca e della didattica. Lavoro appena iniziato e
terribilmente complesso quello cui si sono accinti i componenti del Nucleo,
formato da tre esperti (due interni e uno esterno all’ateneo) di valutazioni
aziendali. Il Nucleo è integrato da tre professori aventi esperienza di governo
universitario e da un esperto esterno per le valutazioni che concernono la
ricerca e la didattica.
I
problemi della didattica e degli studenti sono anche gravi problemi logistici
ed edilizi. Colgo dunque qui l’occasione per descrivere lo stato del piano
edilizio di ateneo. Le scelte dell’ultimo piano edilizio del 1987, che ho
sempre sostenuto dovessero essere confermate nelle linee generali, sono quelle
di un inserimento urbano dell’ateneo per poli disciplinari omogenei,
abbandonando gradualmente e nei limiti del possibile l’antico scenario a
macchia di leopardo. In questo quadro proprio qualche giorno fa l’università ha
preso in consegna, come previsto, essendo finiti i lavori, il grande edificio
della ex fabbrica Marzotto che ospita già il polo didattico di matematica,
fisica e informatica intitolato al matematico pisano del ‘200 Leonardo
Fibonacci (25 aule nuove per un totale di circa 2.000 posti) e tre piani già
attrezzati e utilizzati di laboratori didattici di informatica e fisica, e che
vedrà nei prossimi mesi, dopo i traslochi, la costituzione di una grande
biblioteca interdipartimentale e il funzionamento di una serie di laboratori di
ricerca del dipartimento di fisica con circa 50 studi per i relativi docenti,
tecnici e collaboratori studenti, laureati e dottori di ricerca. Desidero
puntualizzare che il completamento dei lavori con le sistemazioni esterne, di
particolare interesse per l’arredo urbano del luogo e per la fruibilità diretta
da parte dei cittadini dell’area ex Marzotto anche in contatto visivo diretto
con le attività universitarie di didattica e di ricerca, è al momento impedito
dalla presenza bisettimanale del mercato ambulante, che già dà forti
preoccupazioni per la sicurezza di migliaia di studenti non raggiungibili da autoambulanze
e mezzi di soccorso.
Si è
trattato di un imponente lavoro edilizio, conclusosi in poco più di cinque anni
con una spesa complessiva di circa 53 miliardi, finanziati per 40 miliardi dal
fondo FIO del 1989, che ha portato al recupero per l’Università e per la città
di un edificio industriale interno alle mura storiche dismesso più di
trent’anni fa. Purtroppo il recupero di tutto il complesso industriale ex
Marzotto non è ancora possibile per carenza di finanziamenti (il FIO 1989 è
stato l’ultimo grande finanziamento nazionale dell’edilizia, prima della grave
crisi sia finanziaria che istituzionale dell’ultimo quinquennio dovuta anche
alla messa in luce di diffusi e profondi meccanismi di corruzione in questo
campo), anche se tale recupero appare necessario per completare il piano di
insediamento dei dipartimenti di fisica e di informatica e quindi liberare gli
edifici attualmente occupati. Ci auguriamo che anche gli enti locali, e in
special modo il Comune, sentano come propria l’esigenza di questo completamento
e ci aiutino nel trovare i finanziamenti e nel superare i non pochi ostacoli
burocratici. Nello scorso mese di giugno è stato approntato, per partecipare ad
un bando di finanziamento su fondi della comunità europea, un nuovo progetto di
recupero del secondo edificio industriale dell’area, attualmente abbandonato e
in rovina, che permetterebbe all’ateneo il recupero edilizio a costi 1995 un
terzo inferiori a quelli previsti nel 1989 e con funzionalità decisamente
migliore. Ci auguriamo che esso possa trovare favorevole accoglienza presso gli
enti di controllo del territorio, superando qualche difficoltà che si è
registrata in fase iniziale e pur essendo ovviamente l’ateneo disponibile a
recepire le loro esigenze.
Sono
ripresi, purtroppo faticosamente e al termine di iter defatiganti, i lavori al
nuovo dipartimento di ingegneria aerospaziale nell’area Scheibler, che
dovrebbero essere conclusi nel giro di qualche mese. Dal momento in cui il
consiglio di amministrazione ha sbloccato i lavori al momento in cui l’impresa,
avuti tutti i pareri degli enti di controllo, è rientrata in cantiere sono
dovuti passare sedici mesi! E già diciotto ne sono passati per vedere finalmente
e ultimamente approvata la ripresa dei lavori all’ospedale veterinario di S.
Piero a Grado: speriamo che tra breve anche lì l’impresa possa riaprire il
cantiere. Ciò è avvenuto nonostante l’impegno eccezionale e personale del
prorettore per l’edilizia e l’impiantistica Aldo Frediani e nonostante che
addirittura il rettore personalmente sia dovuto andare a sollecitare delibere e
a richiedere e fornire chiarimenti.
Nel
prossimo anno invece aprirà il cantiere per il nuovo polo didattico di Piazza
dei Cavalieri, che sarà edificato sul retro della Scuola Normale e sostituirà
l’attuale palestra prefabbricata. Il progetto esecutivo è stato consegnato, il
finanziamento è già disponibile e quindi spero che non sorgano ostacoli. Questo
polo didattico, con due grandi aule da 400 posti, dovrebbe finalmente dare
qualche sollievo al settore umanistico, e in particolare al settore della
giurisprudenza e delle scienze politiche, i cui numerosissimi studenti del
primo anno ancora oggi devono essere ospitati in cinema o in palestre
indecorose. La carenza di aule grandi e medie è comunque ancora forte, e
purtroppo non si intravedono soluzioni alla proposta avanzata già da due anni
di poter avere, anche fuori dal centro storico, un polo didattico di ateneo per
le grandi aule.
Sempre
per parlare di poli didattici, vi è già un accordo di massima con l’azienda
ospedaliera pisana per realizzare un polo didattico per la facoltà di medicina
e chirurgia nell’area dell’ospedale di Cisanello, il che svincolerebbe numerose
aule nel centro storico a favore del settore umanistico e del settore
biologico-naturalistico che qui rimarranno insediati. Inoltre tale polo
didattico sarebbe consono alla previsione a lungo termine di un insediamento di
tutta l’attività della Facoltà e dell’Ospedale di S. Chiara nell’area di
Cisanello.
E’
infine disponibile pronto per essere appaltato il progetto per il nuovo
dipartimento di ingegneria elettronica, informatica e delle telecomunicazioni
nell’area Scheibler mentre è agli organi di controllo il progetto esecutivo per
l’insediamento nella stessa area dell’istituto di tecnologia meccanica della
facoltà di ingegneria, il cui spostamento permetterà di trovare spazio al
dipartimento di chimica e chimica industriale, attualmente sovraffollato e
senza sufficienti spazi didattici.
Tutte
queste grandi scelte edilizie erano già presenti nel piano edilizio 1987.
Desidero anche citare, purtroppo brevemente per ovvie ragioni di tempo, altre
realizzazioni edilizie di medio valore ma di notevole importanza. Entro il
prossimo anno dovrebbero essere conclusi i lavori per l’insediamento a Palazzo
Scala, in Via S. Maria, del dipartimento di anglistica, che troverà così una
sede unica e senza i gravi problemi, anche di sicurezza per il grande numero di
studenti, di cui soffre oggi. Inoltre sono entrate in funzione le nuove
segreterie studenti nell’area ex Marzotto ed è stato così lasciato al
proprietario il vecchio edificio di Via Maffi, anch’esso fonte di gravi
preoccupazioni per la sicurezza nei momenti di grande affollamento degli
studenti oltre che abbastanza inadatto dal punto di vista funzionale. In realtà
la situazione della segreteria studenti non è ancora soddisfacente dal punto di
vista logistico, ma non si è trovato il luogo e il modo di realizzare una
moderna e ben attrezzata segreteria studenti che unifichi le tre sedi attuali,
tenendo conto che la maggior parte delle pratiche (ma non l’iscrizione) potrà
essere attuato con un sistema telematico oppure con il decentramento delle
competenze alle facoltà e ai corsi di laurea e diploma.
Anche
se purtroppo il trasferimento del CNR a S. Cataldo appare assai più lento di
quanto era stato previsto dallo stesso CNR, si pensa che questo possa avvenire
nel corso del 1997. Ciò libererebbe in particolare una serie di edifici
universitari in Via S. Maria, per il cui recupero è in fase finale un nuovo
progetto di massima per il recupero, che diventa davvero interessante per la
nuova idea di creare una sorta di campus umanistico utilizzando tutto il
comparto tra Via Paoli e Via S. Maria come un unico insediamento, aperto nei
suoi spazi aperti anche alla città. In quest’area, eliminando gli edifici
provvisori interni, si potrebbe ottenere anche una sede moderna e funzionale
per una grande biblioteca unificata dei dipartimenti dell’area letteraria.
Collegato a questo progetto, che darebbe finalmente spazi sufficienti e
unificati a molti dipartimenti e permetterebbe di lasciare edifici inadatti in
affitto, vi è un altro progetto per l’insediamento nell’edificio dell’attuale
dipartimento di fisica, che tra l’altro è contiguo alla Domus Galilaeana, di
tutti i piccoli ma interessanti musei universitari, sull’asse turistico di Via
S. Maria che congiunge Piazza dei Miracoli con i Lungarni.
Ritengo
infine che sia stato un successo notevole di Pisa aver ottenuto dalla Regione
Toscana, alla fine di un iter condotto con un intenso impegno comune da parte
di università, azienda per il diritto allo studio e comune, un finanziamento di
circa 22 miliardi per realizzare circa 500 nuovi posti letto in nuove case
dello studente. L’ateneo ha messo a disposizione alcune aree, a S. Cataldo e in
Via di Parigi, e sono in corso le complesse pratiche amministrative per
pervenire ai progetti e agli appalti.
Quando
ciò sarà realizzato, le disponibilità per alloggi studenteschi pubblici saranno
raddoppiate rispetto all’attuale, anche se rimarremo ben al di sotto degli
standard che sarebbero auspicabili in una città universitaria come Pisa.
Qualche interesse per interventi di carattere privato in questo campo (cioè la
realizzazione di case dello studente private) si sono recentemente manifestati,
e l’università ha già espresso attenzione e interesse a questo tipo di
iniziative, che gioverebbero ad una migliore sistemazione abitativa di studenti
provenienti da famiglie di condizioni economiche non disagiate, creando
occasioni di vita studentesca comunitaria e contemporaneamente allentando la
pressione sul mercato degli appartamenti per famiglie affittati agli studenti.
Pisa
è ancora scelta come sede universitaria da migliaia di studenti che provengono
da altre province e regioni (circa 10.000 sono coloro che vi prendono casa,
secondo un recente lavoro statistico originato dal questionario distribuito
agli studenti che si sono iscritti nel 1994/95, in corso di lettura automatica
e di analisi dei dati) e credo sia importante consolidare questo aspetto e la
sua immagine di “città a misura di studente”. In questo senso ritengo molto
apprezzabile l’impostazione data al problema dall’amministrazione comunale nel
suo recente documento “Patto per la città”: i nostri studenti hanno diritto ad
una vera e propria particolare “cittadinanza”, con i suoi benefici anche se
temporanei.
Qualche
disponibilità di bilancio ha indotto a prendere in considerazione la
possibilità che l’ateneo provveda a qualche acquisto di immobili
particolarmente interessante. Sono già avanzate le trattative per il
completamento dell’acquisto del terreno dell’area ex Marzotto e della palazzina
ex CRAL Marzotto, che dovrebbe essere adibita a sede del consiglio degli studenti
e a centro polifunzionale di servizi studenteschi autogestiti (sala assemblee e
cineforum, uffici per i gruppi studenteschi, spazi ricreativi, etc.).
Nonostante
un accenno qualche minuto fa, ritengo opportuno ritornare al problema dei
rapporti internazionali nel campo della didattica e della ricerca, al quale nel
nuovo schema organizzativo è stato destinato uno specifico autonomo ufficio dei
rapporti internazionali e con le imprese per evidenziarne il ruolo strategico
che si intende dare a questi rapporti. II prorettore Calabi ha riorganizzato
interamente l’area dei rapporti internazionali, creando anche l’area della
didattica europea in vista anche dell’inizio del programma SOCRATES per il
prossimo mese di giugno, un programma estremamente impegnativo in cui la
mobilità studentesca dell’ERASMUS viene ad essere integrata ed ampliata in una
serie di rapporti istituzionali con altre università straniere mediante un vero
e proprio contratto istituzionale da stipulare con la Commissione Europea. La
definizione dei networks di atenei vede tutte le università europee, e anche la
nostra, in una fase di scelte tattiche e strategiche non banali e molto
competitive.
Per
avere un’idea solo grossolana delle dimensioni del nostro impegno
internazionale, la nostra università ha stipulato 42 convenzioni con atenei
stranieri e partecipa a 72 programmi ERASMUS per un totale di circa 500
studenti stranieri che ogni anno vengono a Pisa e altrettanti nostri studenti
che si recano in altri paesi europei.
I
rapporti internazionali sono poi ovviamente particolarmente vivi nel campo
della ricerca, sia nei programmi generali di mobilità (Human Capital and
Mobility, Alpha per 46 contratti finanziati), sia nei programmi specifici del
IV programma quadro o analoghi per i quali si può valutare in circa 70 i
programmi finanziati a docenti della nostra università.
Ma
la ricerca e l’innovazione tecnologica, come la formazione professionale,
finanziate dall’Unione Europea hanno anche una componente italiana su scala
regionale per i programmi nell’ambito dei fondi strutturali e del fondo sociale
europeo. Qui il prorettore Strumia ha seguito una vicenda molto complessa,
lavorando di concerto con il Consorzio Pisa Ricerche, di cui tra l’altro sono
stato eletto presidente quasi a voler segnalare la particolare natura di
braccio operativo dell’ateneo e degli altri centri di ricerca pisani di questo
consorzio che recentemente è stato rinnovato fino al 2004 e che costituisce
un’importante realtà pisana.
Tutti
questi finanziamenti hanno sempre una natura compartecipativa con le piccole e
medie imprese, o, per meglio dire, sono programmi rivolti direttamente alle
piccole e medie imprese che intendano apportare innovazioni tecnologiche in
collaborazione con l’università. Non vorrei qui ripetere ciò che tante volte ho
detto sul fatto che l’Università di Pisa è l’università di elezione del vasto
bacino della Toscana Occidentale formato da quattro province, con interessi
anche verso Grosseto e La Spezia. In questa direzione la convenzione stipulata
con l’Unione Industriale Pisana - con la quale si sono intessuti rapporti
davvero ottimi di collaborazione - si è estesa naturalmente e produttivamente
alle associazioni industriali di Lucca e Livorno, in una collaborazione che ha
fatto centro attorno all’università e che forse può andare anche ben oltre i
temi strettamente universitari, come nel caso della costituzione della società
Aurelia del parco scientifico e tecnologico della Toscana Occidentale
recentemente costituita.
A
questi rapporti con le piccole e medie imprese, così come a quelli con le
grandi imprese del territorio - e mi limito a citare Piaggio e S. Gobain -
l’università tiene molto ed è fortemente interessata ad estenderli.
Un
deciso passo in avanti è stato fatto per la rete di ateneo: il progetto di una
rete privata di ateneo per la trasmissione dati per la ricerca e per la
didattica è stato di fatto completato e, in alcuni punti nevralgici, già
attivato. Questa infrastruttura, quando sarà completata, ci porrà
all’avanguardia delle applicazioni cittadine della telematica, nelle quali è
già in atto una collaborazione forte tra tutte le istituzioni pubbliche della
città.
Non
posso concludere questo discorso senza due altri accenni a temi molto
importanti. Alla costituzione dell’Azienda Ospedaliera Pisana non è purtroppo
ancora corrisposta la stipula dell’apposita convenzione che regolerà l’apporto
universitario alle attività assistenziali dell’azienda. Il ritardo è dovuto a
difficoltà e ritardi della Giunta Regionale, rinnovata nella scorsa primavera,
che deve approvare un protocollo generale di intesa tra Regione e università al
quale ormai da anni lavora con competenza e decisione il prorettore Mariani.
Dopo alti e bassi nella trattativa, si può forse dire che ora siamo nella fase
finale, o almeno così speriamo. Nel frattempo un’apposita commissione mista
creata dal rettore e dal direttore generale dell’azienda dott. Bizzarri ha
cercato di preparare il terreno affinché la stipula della convenzione locale
possa seguire da vicino al protocollo di intesa regionale. Più avanzate,
invece, le trattative per i protocolli di intesa relativi alla istituzione dei
diplomi universitari di tipo medico con insediamenti parziali presso le aziende
sanitarie del bacino naturale dell’università di Pisa.
Un
lungo lavoro, cui è stato delegato il prorettore vicario Paduano che oltre a
ciò ha con me condiviso tutte le scelte importanti di politica universitaria e
che desidero qui affettuosamente ringraziare con tutti gli altri prorettori, ha
infine portato all’approntamento della pianta organica del personale
tecnico-amministrativo dell’ateneo dopo la verifica dei carichi di lavoro
previsti dalla legge. II nostro ateneo dovrebbe essere il primo in Italia ad
aver avuto approvata dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la
Presidenza del Consiglio la pianta organica e quindi a poter aprire di nuovo il
reclutamento. Sul bilancio 1996 è stata riservata una cifra che dovrebbe
permettere l’assunzione di poco più di cento unità di personale, e mi fa
piacere pensare che questo sia ancora un altro importante contributo alla città
da parte della sua università.
Tante
altre cose avrei ancora da dire, ma il tempo a mia disposizione si è concluso.
Non vorrei però dimenticare che dietro tutta la nostra attività vi è il nostro
impegno di professori, di ricercatori, di studenti. Dicevo ieri, concludendo il
bellissimo e significativo convegno sull’etica della ricerca biomedica che ha
preceduto questa inaugurazione, che:
“In
un periodo in cui sembra che l’opinione pubblica, non solo italiana, sia come
incantata dall’effimero e dal “gridato”, dall’approssimativo e dal semplice,
desideriamo riaffermare l’importanza dei valori fondanti della nostra civiltà e
della riflessione pacata, colta e critica su di essi, l’importanza dell’esattezza
e della verifica insieme all’accettazione della complessità di ogni sistema non
banale, quasi in mimesi del famoso teorema di logica matematica dovuto a Kurt
Godel. Questi stessi sono i valori tradizionali dell’istituzione universitaria,
come è nata e si è sviluppata in tutto il mondo a partire dalla nostra Europa
medievale.”
E in
questa direzione prendo in prestito le parole di Erwin Schrodinger in una
conferenza che lesse a Dublino nel 1950: “Non perdete mai di vista la funzione
della vostra particolare materia nel grande corso della tragicommedia della
vita umana; restate a contatto con la vita, non tanto con la vita pratica,
quanto con gli ideali fondamentali della vita, che sono sempre tanto più
importanti; e la vita resti in contatto con voi. Se non lo potrete, a lungo
andare, qualunque cosa si dica di ciò che avete fatto, la vostra opera sarà
stata vana.”
Con
l’auspicio che possiamo essere capaci di essere i destinatari dell’esortazione
del grande scienziato, dichiaro ufficialmente e solennemente aperto l’anno
accademico 1995-96 dell’Università di Pisa, 652° dalla fondazione.