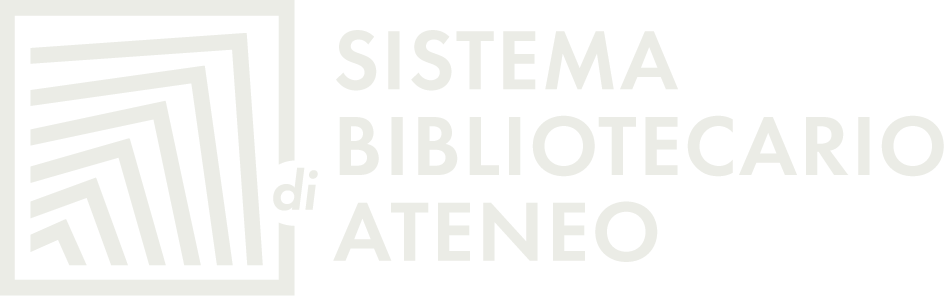Nicola Badaloni fu Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa nei giorni difficili, complessi, importanti dell’epoca del ’68. Erano i giorni della politica e dei movimenti, dei rapporti altrettanto difficili, complessi, importanti tra movimento studentesco e movimento operaio, il tempo della ricerca di una politica capace di dare sbocco a quel che di nuovo era esploso allora.
Badaloni, intellettuale legato alla più grande organizzazione del movimento operaio d’Occidente, perché questo era allora il Partito Comunista Italiano, appartiene alla generazione di quegli studiosi di rango che hanno saputo essere attivi tanto nel campo della ricerca e dell’insegnamento, quanto in quello della politica.
Come Preside riuscì ad avere un consenso assai vasto anche grazie ad una capacità di governare assicurando, nelle regole, autonomia a studenti e docenti. Egli riuscì a garantire, nello stesso tempo, libertà di ricerca e di insegnamento e senso democratico della politica. Fu alla testa di manifestazioni spontanee di piazza, di studenti e docenti della facoltà, quale quella contro il sequestro di Aldo Moro. Erano momenti difficili e la facoltà fu sempre un terreno di confronto e di riflessione di fronte agli eventi sociali e politici. Era un modo, che oggi appare assai lontano, di educare i giovani al sapere critico. La partecipazione politica e democratica non fu mai considerata come qualcosa di estraneo alla vita intellettuale dell’Università e della Facoltà, ma anzi veniva concepita come un bagaglio essenziale della formazione dello studente. Badaloni dovette rinunciare alla carica di Preside per problemi di salute.
Il consenso lo ebbe sempre. I suoi studi sono ben noti: Bruno, Campanella, Vico, Marx, Gramsci per non citare che alcuni, i più grandi tra i filosofi moderni e contemporanei, che furono oggetto della sua analisi e della sua riflessione.
Di tradizione e di cultura storicista, Badaloni seppe cogliere con apertura e intelligenza i movimenti intellettuali che, in seno al marxismo europeo, spingevano verso nuove letture, teoriche e politiche, di Marx.
Marxista, Nicola Badaloni appartiene alla grande tradizione degli storici della filosofia.
L’opera Inquietudini e fermenti di libertà nel Rinascimento italiano ne è un esempio: l’indagine storiografica si accompagna alla riflessione teorica. Badaloni non si è mai accontentato di ridurre la filosofia al chiarimento filologico, ma ha concepito la ricerca come un’indagine complessa atta a individuare nel pensiero di un filosofo sia gli aspetti riguardanti i paradigmi del suo tempo, sia le caratteristiche peculiari e originali anche là dove questo autore non rientrava negli schemi storiografici basati su una certa definizione di modernità e/o di progresso. Esemplare tra gli altri è a tale proposito il suo bellissimo saggio sui fratelli Della Porta. Contestando a Corsano l’isolamento delle teorie di Giovan Battista Della Porta nei confronti della cultura del suo tempo e in particolare di quella napoletana, Badaloni mostra gli elementi di modernità pur all’interno di una concezione scientifica errata.
“L’interesse scientifico nasce in Della Porta dalla sua passione di sperimentatore...
Lo storico della scienza dovrà comunque non solo valutare opportunamente la modernità della utilizzazione pratica, ma anche il significato dell’ipotesi teorica di questa forza unitaria operante con una sua logica, e con proprie leggi che si riportano alla immagine di una natura attivamente tendente alla propria autoconservazione. Il fatto che questa ipotesi sia errata non può fare dimenticare che essa ha permesso di collegare fenomeni diversissimi come quelli fisici, chimici, meteorologici, biologici, liberando la mente da spiegazioni tradizionali, e lasciando aperto il campo a nuovi approfondimenti”.
Badaloni cercava di individuare gli aspetti innovativi, se non di rottura, anche là dove il contesto teorico e culturale appariva, ai suoi stessi occhi di studioso, superato e sbagliato. Vi erano ragioni di metodo e ragioni di libertà: “I tagli netti ed assoluti - così Badaloni conclude questo mirabile saggio - cedono il posto ad una serie di passaggi di maturazione ideale e metodologica che, se non ci fanno perdere il limite di validità della ricerca considerata, non ci fanno neppure commettere l’errore di considerare una componente come l’unica privilegiata, e la storia come procedente in un’unica direzione”.
In una intervista a Vittoria Franco che Remo Bodei assai opportunamente riporta in un suo scritto dedicato a Badaloni, quest’ultimo dice a proposito dello storicismo: “Oggi si parla dello storicismo come di una teoria della storia e non di una penetrazione comparativa della diversità degli ambienti storici illuminata da una coscienza critica”. Badaloni, attento com’era alla realtà storico-politica contemporanea e ai fermenti culturali, teorici e politici, concepì in questi termini lo storicismo e lo rivisitò alla luce dell’esperienza del ’68 e delle lotte del movimento operaio degli anni successivi.
Rimasi stupito quando, in una recente intervista, egli confessò che il filosofo che più lo aveva attratto era stato Heidegger. Ma poi, ripensandoci, avendo collaborato con lui per anni, mi resi conto che egli aveva sempre avuto un’inquietudine che lo faceva oscillare intellettualmente tra alcune certezze di una tradizione a cui apparteneva e che non avrebbe mai tradito e alcune verità che provenivano da altre tradizioni, da altri filosofi. E questa produttiva inquietudine finiva con il conciliare il suo sterminato bisogno di sapere con la riflessione storico-filosofica, la voglia dell’erudito con il desiderio del filosofo.
Lina Bolzoni ha ricordato il caffè delle 11 al Battellino a Pisa, occasione di scambi di idee, sulle ricerche, sui libri, sulla politica.
Era un tempo in cui la politica veniva ancora vissuta come una forma di conoscenza che si accompagnava alla critica e che attraversava i saperi nella ricerca di un senso della storia fondato sulla libertà e sull’eguaglianza degli uomini. Tutto questo può apparire retorico o desueto oggi nell’epoca della competition, dell’individualismo, della globalizzazione. Ma non lo è. Non sono convinto che viviamo giorni migliori.
Badaloni fu maestro di tutti noi.
Alfonso Maurizio Iacono
Da: Comune notizie: rivista del Comune di Livorno, n. 52-53 (2005), pp. 13-15.